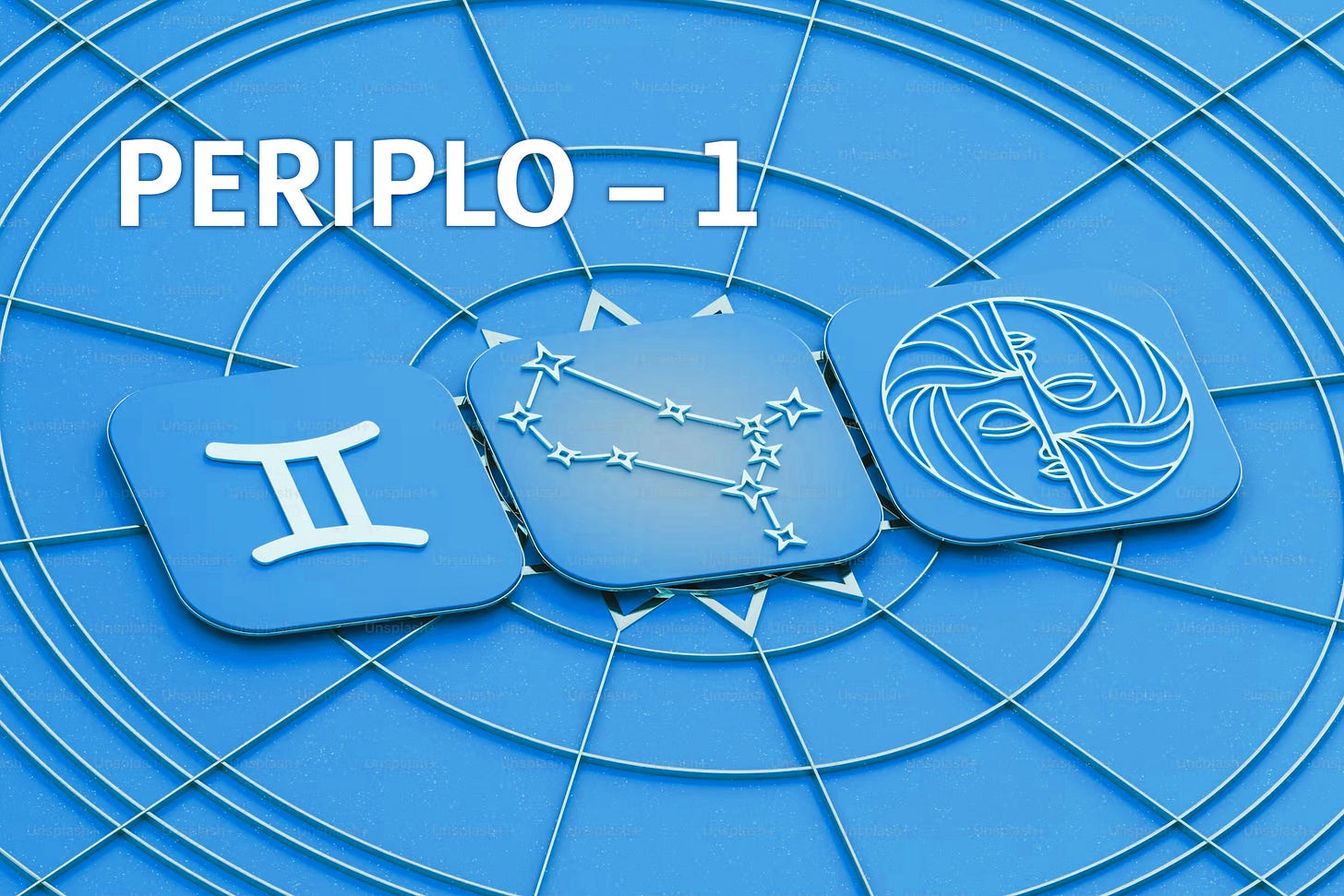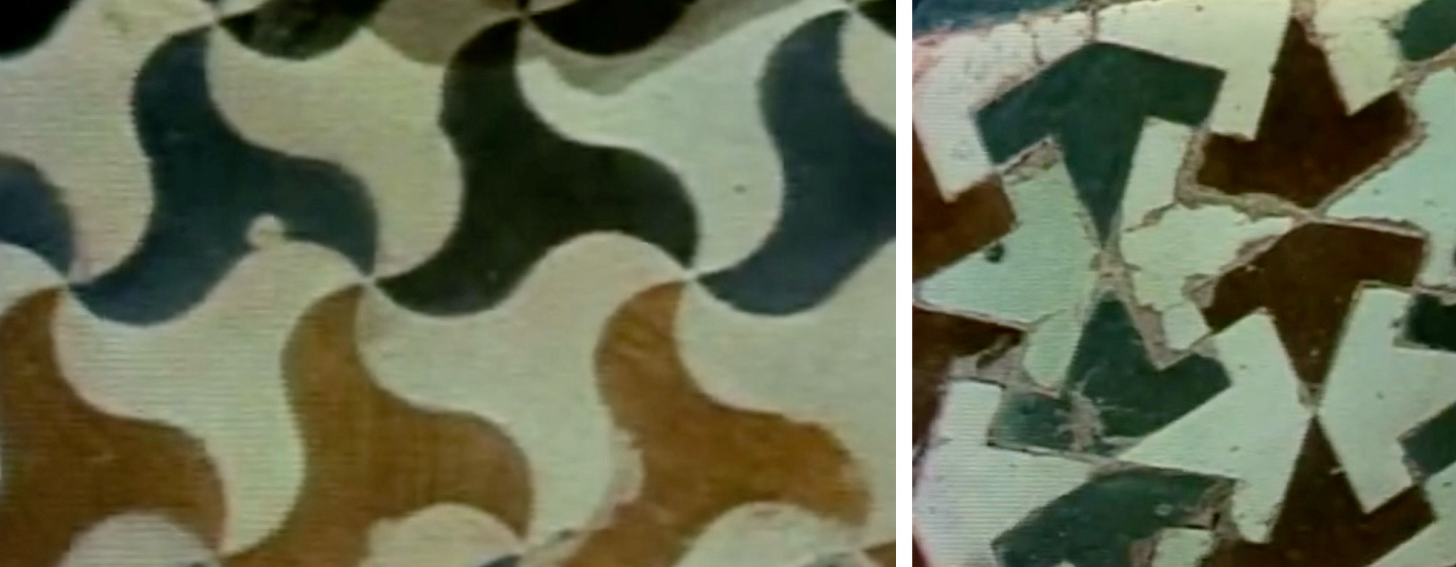Periplo – Giugno 2025, n. 1
Cinque approdi tra scuola, memoria e desiderio educativo
Introduzione
Questo è il primo numero di Periplo, una nuova forma di scrittura mensile che inaugura la rinnovata sezione del sito che fino a qualche tempo si chiamava “Diario di Ulisse” ed oggi è “Arcipelago Pedagogico”, in continuità ideale ma con un respiro diverso.
Questo articolo, come quelli che seguiranno, nasce come un piccolo viaggio a tappe, un periplo. Non un percorso lineare, ma una navigazione che tocca isole, approdi, pensieri e memorie. Ogni sezione corrisponde a una sosta, a un punto d’osservazione, a un frammento di esperienza che si intreccia con il tema dell’educazione.
Scrivo da dentro la scuola, ma anche ai margini. Osservo, studio, raccolgo materiali, leggo e, quando posso, agisco. In queste pagine si intrecciano riflessioni personali, scoperte didattiche, incontri mancati e ritrovati, esperimenti pedagogici e qualche ricordo.
Ho deciso di introdurre ogni sezione con un breve abstract per permettere al lettore di orientarsi, saltare, scegliere. Non è necessario leggere tutto, né farlo in ordine: ognuno può trovare la propria traiettoria tra le righe.
Sommario
1. Senza un maestro, senza degli allievi, senza l’agire
Una riflessione personale sul bisogno di maestri e sull’assenza di veri incontri trasformativi. Un percorso tra fonti letterarie e spirituali, segnato dalla mancanza di un agire educativo concreto. Un bivio: da un lato il sapere accademico, dall’altro la pratica come via di liberazione. Ma senza allievi, che educazione è?
2. Storia di una ricerca andata a buon fine dopo due anni
A partire da un interesse per le diverse dimostrazioni del teorema di Pitagora, questa sezione ricostruisce un percorso di ricerca che conduce alla scoperta delle geometrie dell’Alhambra. Un viaggio che attraversa il lockdown, YouTube, appunti digitali e infine un libro prezioso che unisce arte, matematica e didattica. Parole chiave: tassellatura, compiti autentici, bellezza.
3. La mappa di don Milani
Una piccola storia educativa che inizia con un viaggio in Germania nel 1961 e si intreccia con un oggetto didattico diventato iconico: la mappa dei viaggi di Gesù usata da don Lorenzo Milani. Tra illustrazione, catechesi e grafica narrativa, la mappa si rivela uno strumento potente e ancora attuale.
4. Media digitali ed educazione informatica
Una sezione che si interroga sul ruolo dell’informatica e delle competenze digitali nelle scuole Steiner-Waldorf. Un’indagine personale che attraversa documenti, esperienze scolastiche e pratiche internazionali, fino ad approdare all’approccio HERMMES, che propone un’educazione olistica e consapevole per l’era digitale.
5. Gutenberg, l’eBook e il tema di maturità 25 anni dopo
A venticinque anni dall’esame di maturità, quella lontana traccia riaccende i pensieri sulla scrittura, sulla stampa, sulla lettura. Il ricordo di un vecchio tema scolastico diventa occasione per fare il punto sul proprio percorso e su ciò che oggi conta davvero.
1. Senza un maestro, senza degli allievi, senza l’agire
Una riflessione personale sul bisogno di maestri e sull’assenza di veri incontri trasformativi. Un percorso tra fonti letterarie e spirituali, segnato dalla mancanza di un agire educativo concreto. Un bivio: da un lato il sapere accademico, dall’altro la pratica come via di liberazione. Ma senza allievi, che educazione è?
1.1 Senza un maestro
«Il maestro è Lei.» Così mi disse il professor Riccardo Romagnoli, congedandomi dopo una splendida giornata trascorsa insieme. Una frase che ben rappresenta il suo lungo cursus honorum: maestro di ginnastica, allenatore di calcio, professore alle medie, docente alle superiori, preside di un liceo artistico, creatore di scuole e percorsi professionalizzanti, innovatore in ambito didattico, direttore di un ITS e di un’accademia di belle arti. Un pozzo di idee. Un uomo che ha saputo alimentare e innaffiare i semi della propria conoscenza, consapevolezza, bontà d’animo e creatività.
Quando l’ho incontrato, non ha parlato di grandi maestri. Ha raccontato piuttosto delle tante collaborazioni vissute, dei sogni coltivati con tenacia, e delle difficoltà affrontate lungo il cammino, senza mai arrendersi.
Nella mia esperienza di vita ho cercato maestri un po’ ovunque, senza mai incontrarne uno in carne e ossa che mi vedesse davvero, che mi riconoscesse. Avrei voluto qualcuno da cui ricevere insegnamenti autentici. Ho fatto spesso dei buchi nell’acqua.
Gli unici veri maestri li ho incontrati nei libri che hanno lasciato, o nei racconti scritti da altri sulla loro vita. È accaduto così per Frank Bettger, Alberto Manzi, Giuseppina Pizzigoni, Maria Montessori, Lodovico Pavoni, Thích Nhất Hạnh, Martin Buber, la monaca Jetsunma Tenzin Palmo e Sister Chân Không.
1.2 Senza allievi e senza agire
L’educazione è azione, è agire. Non si può parlare di pedagogia senza metterla in pratica.
A me, però, questa possibilità oggi manca. Vivo immerso nella scuola dalla mattina alla sera, ma senza allievi, privo di quell’agire educativo che dà senso e vita all’educazione stessa.
Ho percorso a lungo il sentiero dell’educare, ed ora mi trovo a un bivio. Il primo cartello indica una svolta a sinistra: “laurea in scienze dell’educazione”, seguita da una laurea specialistica. Implicherebbe lavorare e iscriversi a un corso online, studiare da solo, senza agire, ripetere da solo, senza sperimentare, incontrare maestri e maestre nei libri, ma senza poterli interrogare.
Il secondo cartello punta a destra. C’è scritto: «pratica per la liberazione». Nient’altro. Spinge alla scoperta di sé stessi, a quel nosce te ipsum spesso ignorato. Spinge alla scoperta dell’amore per sé stessi e per gli altri.
Ho tentato di avvicinarmi al mondo delle scuole parentali e delle scuole Steiner-Waldorf. Le prime, per ora, non offrono compensi sufficienti per viverci; e non ho trovato una scuola che sia anche una comunità, in stile eco-villaggio, dove potersi trasferire e vivere pienamente.
Quanto alle seconde, mi sono proposto più volte, ma senza mai ricevere risposta – né positiva, né negativa. Ringrazio chi non mi ha risposto: mi ha permesso, indirettamente, di indirizzare altrove le mie energie.
2. Storia di una ricerca andata a buon fine dopo due anni
A partire da un interesse per le diverse dimostrazioni del teorema di Pitagora, questa sezione ricostruisce un percorso di ricerca che conduce alla scoperta delle geometrie dell’Alhambra. Un viaggio che attraversa il lockdown, YouTube, appunti digitali e infine un libro prezioso che unisce arte, matematica e didattica. Parole chiave: tassellatura, compiti autentici, bellezza.
2.1 Dal teorema di Pitagora all’Alhambra
Nel maggio 2020, durante il lockdown, una mattina mi riproposi di approfondire le diverse dimostrazioni del teorema di Pitagora. In passato avevo già esplorato l’argomento, arrivando a realizzare un’animazione 2D al computer che dimostrava il teorema attraverso il Tangram.
Quel pensiero, però, continuava a tornarmi in mente, a distanza di oltre un anno dalla realizzazione del video. Mi succede spesso: certe curiosità si trasformano in una sorta di tarlo, un’eco che non si affievolisce mai. È fame di sapere.
Così, non avendo molto altro da fare – a parte cucinare e studiare – iniziai a cercare su YouTube. Dopo un po’ mi imbattei in un video di tale Jacob Bronowski: era una puntata di un vecchio documentario della BBC, straordinario per bellezza e chiarezza. Stavo guardando uno degli episodi della serie The Ascent of Man (L’ascesa dell’uomo1), condotta proprio da Bronowski, matematico, scrittore e divulgatore britannico di origine polacca, a me completamente sconosciuto fino a quel momento.
La sua dimostrazione del teorema di Pitagora si trova nell’episodio cinque, intitolato Music of the Spheres. Dopo averla illustrata su un’isola greca, con il mare alle spalle, Bronowski si sposta in Spagna, all’Alhambra, per continuare a parlare di geometria e mostrare le meraviglie decorative della fortezza.
Quel giorno del 2020 scattai subito alcuni screenshot delle geometrie che mi colpirono.
Le immagini finirono nel mio diario digitale su Milanote.com, assieme ad alcune note storiche sull’Alhambra, sugli ebrei sefarditi e sulla loro espulsione dalla Spagna nel 1492. Come spesso accadeva, e oggi un po’ meno, mi persi nei meandri della storia.
2.1 L’Alhambra con riga e compasso
Poi, un martedì dell’anno successivo – era il 29 giugno 2021, la stessa data in cui sto scrivendo questo articolo – decisi di riprendere in mano la questione. Volevo capire come si costruivano geometricamente quei motivi decorativi della fortezza. Aprii Google, sezione immagini, e digitai: «alhambra normalizzazione».
Con mia grande sorpresa, e soddisfazione, trovai in breve tempo un libro che ricostruiva proprio quelle geometrie. La scoperta avvenne grazie ad un articolo su un blog e al tweet dell’artista Clarissa Grandi , che mostrava anche alcuni schemi ricreati con GeoGebra.
Sono passati altri quattro anni da quel 2021, e quest’anno mi sono finalmente regalato quel libro: La Alhambra con regla y compás, di Manuel Martínez Vela.
Un testo meraviglioso, corredato anche da un eserciziario (che ancora non possiedo), che permette di esplorare la matematica e la geometria attraverso la costruzione delle tassellature, sia su carta che al computer. È uno strumento ideale per chi lavora nel mondo della moda, del design tessile o della grafica, e vuole esplorare le simmetrie, le rotazioni e i pattern decorativi partendo da un patrimonio storico di bellezza.
Un libro che ispira, e che insegna facendo.
3. La mappa di don Milani
Una piccola storia educativa che inizia con un viaggio in Germania nel 1961 e si intreccia con un oggetto didattico diventato iconico: la mappa dei viaggi di Gesù usata da don Lorenzo Milani. Tra illustrazione, catechesi e grafica narrativa, la mappa si rivela uno strumento potente e ancora attuale.
Nel 1961, come raccontato anche sul sito della Fondazione Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana e i suoi studenti compirono insieme un viaggio in Germania per visitare il Paese e alcune officine. Alcuni di quei ragazzi, in seguito, sarebbero partiti per lavorare proprio in Germania.
Fu durante quel viaggio – o forse prima, chissà – che don Milani si imbatté in una mappa della Palestina particolarmente ricca: vi erano raffigurati tutti i viaggi di Gesù e ben centosette scene tratte dal Vangelo. Don Milani riuscì a farne ristampare una versione italiana, e ancora oggi è possibile acquistarla online dalla Libreria Editrice Fiorentina. Per molti anni fu inclusa nel volume Il Vangelo come catechismo.
Non sono riuscito a ricostruire con precisione le vicende legate alla scoperta e all’adozione di questa mappa. So solo che don Milani ne aveva ottenuto la ristampa, che la faceva colorare ai suoi studenti e che la utilizzava come strumento di lezione.
La mappa fu originariamente realizzata negli anni Trenta da Willi Harwerth (1894–1982), grafico e illustratore tedesco, nonché docente alla Scuola di arti e mestieri di Offenbach am Main (Kunstgewerbeschule).
Nell’estate del 2023, durante uno dei miei pellegrinaggi digitali dedicati alla scoperta dei metodi educativi dei maestri del passato, mi è tornata in mente quella cartina di don Milani. Ho provato a cercarla nuovamente sul web, e ho scoperto che è conservata anche nel portale dei musei digitali della Germania, nella sezione del Museo della Cultura Europea di Berlino. Il museo fa parte del sistema dei musei della città e possiede anche una ricca biblioteca.
La versione in archivio è una ristampa colorata del 1948, firmata dallo stesso autore.
Ho deciso allora di scrivere al museo, utilizzando il pulsante “Contatta il museo” presente in fondo alla pagina. Con mia grande sorpresa ho ricevuto una risposta piuttosto celere e, dopo la pausa estiva, mi è arrivata una scansione in alta definizione della mappa.
Purtroppo non posso riprodurla: il personale del museo ha specificato che l’immagine può essere utilizzata esclusivamente a fini privati, ed è esclusa ogni forma di uso commerciale o pubblicazione.
Qui desidero comunque riportare almeno un paio di particolari, per restituire un assaggio della qualità delle illustrazioni e della vividezza grafica del disegno.
Mappe come questa – e infografiche come quelle di Giorgia Lupi – sono strumenti potentissimi. Permettono di imparare attraverso l’immaginazione visiva, coinvolgendo linguaggi diversi. Possono essere usate per raccontare storie, visualizzare percorsi, costruire significati.
E sono anche un invito per gli studenti a creare le proprie mappe: a disegnare, rappresentare, collegare.
Se non vi è mai capitato di sfogliare un libro di Giorgia Lupi, vi invito a farlo. Toccarlo con mano è parte dell’esperienza.
4. Media digitali ed educazione informatica
4.1 Antefatto
Perfetto Luigi. Procedo con la Sezione 4 – Media digitali ed educazione informatica, articolata nei sottoparagrafi che già avevi previsto. Lavoro come sempre sulla chiarezza, la sintesi laddove utile, e una maggiore coesione tra i blocchi. Mantengo il tono riflessivo e autentico, ma con un ritmo più lineare.
4. Media digitali ed educazione informatica
A partire da un incontro casuale, questa sezione si interroga sul ruolo dell’informatica e delle competenze digitali nelle scuole Steiner-Waldorf. Un’indagine personale che attraversa documenti, esperienze scolastiche e pratiche internazionali, fino ad approdare all’approccio HERMMES, che propone un’educazione olistica e consapevole per l’era digitale.
4.1 Antefatto
All’inizio del 2025 – era febbraio, se non ricordo male – mi ritrovai a cena con un ex studente dei miei corsi, Gabriele. Tra una fetta di pizza e l’altra iniziammo a ricordare i suoi compagni di classe. Tra loro c’era un ragazzo che aveva frequentato una scuola Steiner-Waldorf, proprio qui a Trento. Quando emerse questo dettaglio, Gabriele raccontò di aver visitato varie scuole Waldorf, anche durante un’esperienza Erasmus Plus a Valencia.
Con sorpresa, scoprii che lo aveva fatto per accompagnare la sua fidanzata a diversi eventi pubblici organizzati da quelle scuole. Qualche giorno dopo, in occasione della giornata dell’8 marzo, ci siamo ritrovati al teatro della scuola Steiner-Waldorf di Trento per assistere a una messa in scena dell’Antigone di Sofocle. Le ragazze della IX classe si alternavano nel ruolo della protagonista, mentre i ragazzi sostenevano i ruoli maschili. Un lavoro intenso, sentito, fatto davvero bene.
In passato avevo già provato a propormi come docente presso alcune scuole Steiner-Waldorf, sia parentali sia riconosciute, ma senza esito. Quella sera, però, ebbi l’occasione di conoscere alcune persone dello staff e scambiare qualche parola. Al momento dei saluti accennai al mio interesse e manifestai la volontà di mettermi in contatto con un responsabile. Una delle insegnanti presenti mi rispose che uno dei nodi aperti nella scuola è proprio quello dell’integrazione dell’informatica e delle competenze digitali. Mi disse: «Non è facile capire come coniugare questi strumenti con il nostro approccio».
4.2 Le competenze digitali
Il tema delle competenze digitali, nella scuola e nella vita dei giovani, è ineludibile. Personalmente, metterei sul tavolo come riferimento il DigComp 2.2 – Il Quadro delle Competenze Digitali per i Cittadini, promosso dalla Commissione Europea e adattato in Italia grazie al lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale. È un documento di grande valore, costruito anche con il contributo di docenti italiani, utile per orientare politiche formative concrete.
Nel marzo 2025 ho deciso di approfondire seriamente come le scuole Steiner-Waldorf, in Italia e all’estero, stiano affrontando la questione della cultura digitale. In passato avevo già scritto un breve syllabus per un corso sull’uso dell’iPad, ma questa volta volevo spingermi oltre.
Ho svolto ricerche sia in italiano che in inglese, e ho scoperto una varietà di approcci e materiali molto interessanti, tra cui:
il piano di studi “Media digitali ed educazione informatica”, disponibile in tre lingue, elaborato dalle scuole svizzere e ispirato da un progetto europeo sul tema;
i materiali e le policy di scuole Waldorf americane come la Green Meadow Waldorf School, la Bright Water Waldorf School e la Waldorf School on the Roaring Fork, che propone un modello “Slow Tech”.
Tutte queste risorse mostrano una tensione comune: come integrare la tecnologia senza snaturare l’approccio pedagogico, senza anticipare forzatamente i tempi, ma nemmeno ignorando il contesto attuale.
4.3 Conclusione
Dopo aver letto a lungo i materiali e le esperienze raccolte, mi sono imbattuto in un progetto che propone una visione più ampia e articolata: HERMMES.
Si tratta di un approccio educativo olistico, pensato per accompagnare bambini e ragazzi nella crescita all’interno di un mondo sempre più segnato dalla presenza dei media digitali.
HERMMES è un approccio che riconosce la pervasività del digitale nella vita quotidiana e propone di affrontarla in modo consapevole, evitando sia l’entusiasmo acritico sia il rifiuto ideologico.
Affronta rischi e opportunità, e lo fa guardando all’intera realtà dei bambini e dei giovani, nelle case, nelle scuole, nei rapporti sociali.
Riporto un breve estratto dalle Linee guida del progetto, nella mia traduzione italiana:
Potremmo avere la sensazione di vivere in tempi turbolenti, mentre il mondo intorno a noi cambia in modi che sembrano accelerare e difficili da comprendere. Anche l'esperienza dell'infanzia si sta trasformando, e non solo in positivo. Un fattore significativo di questi cambiamenti sono i media che utilizziamo per comunicare, compresi i crescenti effetti dei social media e la crescente complessità della tecnologia digitale.
È illusorio pensare che scuole e strutture per la prima infanzia possano continuare a svolgere le loro attività senza recepire questi cambiamenti. Per supportare insegnanti, genitori e tutori in questo impegno, le Linee guida HERMMES affrontano domande come: “Come possiamo trasformare le pratiche nelle nostre vite, nelle nostre case e nei nostri contesti educativi in modo che, quando lavoriamo con bambini e ragazzi, possiamo bilanciare gli effetti positivi e negativi dei media e delle tecnologie digitali?”
Un documento che, a mio avviso, meriterebbe attenzione anche nelle scuole pubbliche italiane, dove l’informatica è spesso relegata a una materia curricolare tra le altre, senza una reale riflessione pedagogica trasversale.
5. Gutenberg, l’eBook e il tema di maturità 25 anni dopo
A venticinque anni dall’esame di maturità, quella lontana traccia riaccende i pensieri sulla scrittura, sulla stampa, sulla lettura. Il ricordo di un vecchio tema scolastico diventa occasione per fare il punto sul proprio percorso e su ciò che oggi conta davvero.
Se quest’anno avessi dovuto affrontare di nuovo l’esame di maturità, sarei stato combattuto tra due tracce: quella sul tema del rispetto e quella che presentava un articolo del mio mito, il professor Telmo Pievani.
Sono passati venticinque anni dal mio diploma. Ricordo bene la traccia che scelsi per il tema di italiano: faceva parte della Tipologia B, ambito tecnico-scientifico. Si trattava di scrivere un saggio breve o un articolo di giornale. L’argomento era: “Da Gutenberg al libro elettronico: modi e strumenti della comunicazione”.
Scrissi un testo che, per come ero fatto allora, avrebbe potuto diventare un libro. Amavo – e ancora amo – i libri, la stampa, l’impaginazione. Amo la lettura e la saggistica. Amo scrivere, studiare, insegnare, comunicare.
Oggi, a 44 anni, ho acquisito una consapevolezza più matura: la scrittura non è tutto. Non basta a scuola, non basta nella trasmissione degli insegnamenti, non basta nella relazione educativa. Comunicare è anche altro. È gesto, ascolto, presenza. Ma questo è un altro discorso.
Avevo pensato di riprendere quella traccia di maturità e scriverci un nuovo testo o un articolo per questo blog, ma non ci sono riuscito. I miei interessi, oggi, sono cambiati. Si sono semplificati, concentrati su ciò che ritengo essenziale. La stampa, l’elettronica, i mezzi della comunicazione occupano ancora uno spazio importante, ma non centrale. Oggi sono più interessato alla sostanza delle cose che al loro supporto.
Mi piaceva però concludere questo periplo di giugno proprio con quel ricordo. Con un’immagine che torna, ogni anno, insieme all’estate e agli esami.
Anche quest’anno, davanti a quei ragazzi e ragazze che affrontano prima il tema, poi la seconda prova di Tecniche di Produzione e di Organizzazione e infine l’orale, mi è capitato di commuovermi. Una lacrima che scende silenziosa, mentre li guardo parlare, difendere le loro idee espresse nel project work e nelle slide per il colloquio, raccontare un percorso. È il segno che, sotto sotto, l’educazione continua a toccarmi. Sempre.
Postfazione
Rileggendo queste righe, mi accorgo che nulla è lineare. Né il pensiero, né l’educazione, né la scrittura. Tutto si intreccia: le domande che mi porto dietro da anni, i volti dei ragazzi incontrati, le tracce lasciate da chi ha saputo educare davvero, anche solo con un disegno, una mappa, una scelta.
Scrivere è anche questo: mettere ordine senza ordinare, condividere senza voler spiegare tutto, restituire qualcosa a chi legge – un'idea, un’intuizione, una pausa.
A chiunque sia arrivato fin qui, grazie.