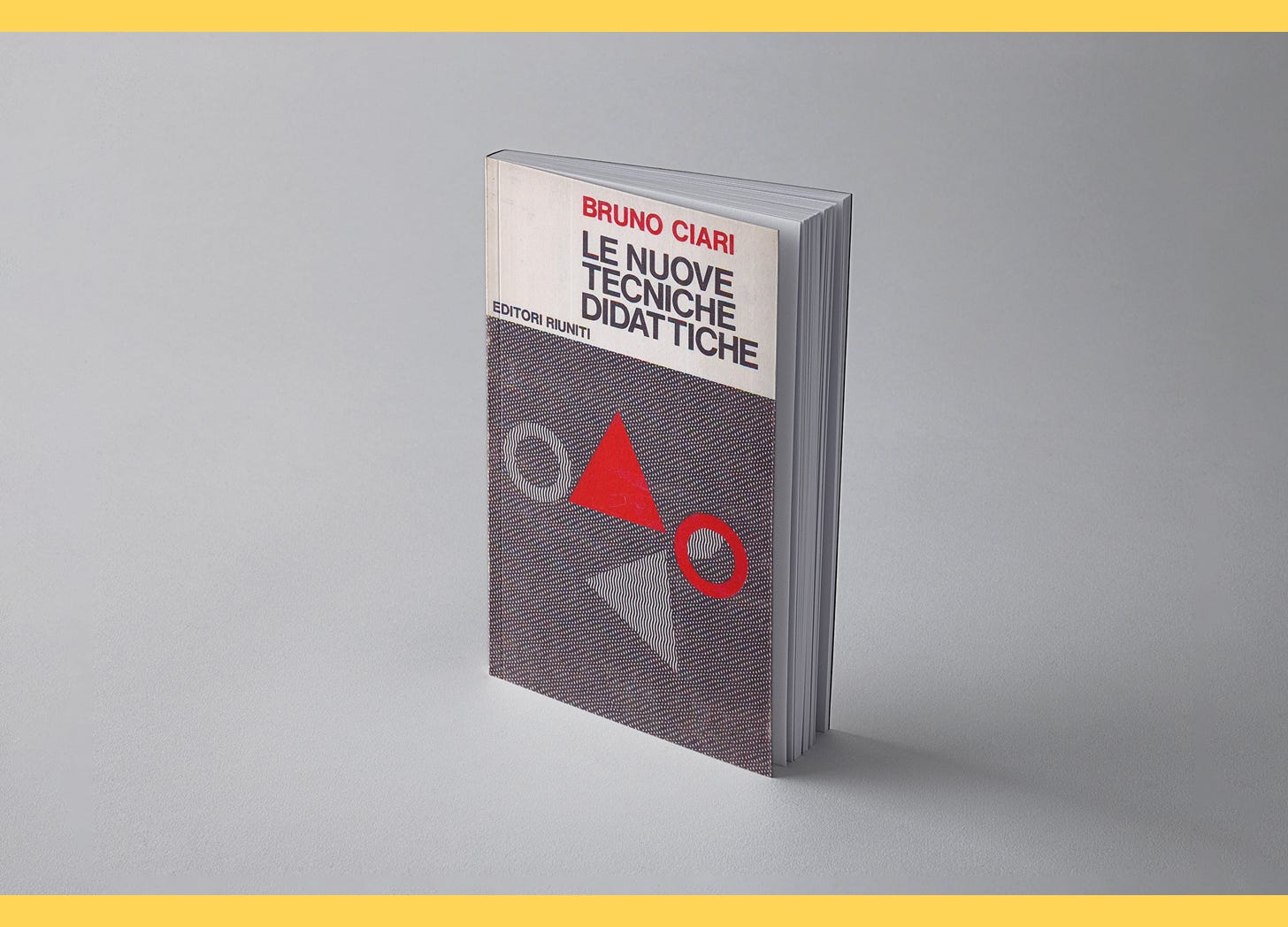Bruno Ciari è citato da tutti. Mario Lodi lo cita, Gianni Rodari lo cita, Tullio De Mauro lo cita. Tanto basta a dargli un posto di rilievo nel panorama pedagogico del XX secolo. Ecco alcune estratti che reputo degni di grande rilievo, tratti dal suo scritto più noto.
Note a margine
Ciari, Bruno, Le nuove tecniche didattiche, Editori riuniti, 1961
Questa è un’opera essenzialmente didattica. Essa vuole innanzitutto aiutare i maestri ad affrontare le difficoltà minute, quotidiane, della vita di scuola; è un’opera che ha per oggetto, quindi, le tecniche, i procedimenti pratici, il “come si insegna”, o, meglio, il “come si aiuta il fanciullo a formare le proprie attitudini intellettuali e morali, a conquistarsi una prima, organica visione del mondo e determinate abilità strumentali”.
Questo non significa che lasceremo da parte, come cosa che non ci riguarda, e dinanzi a cui siamo “neutri”, le finalità e i valori che stanno a fondamento dell’opera educativa. Noi pensiamo di occuparci dei valori ideali, di cui tanta gente si riempie la bocca nei congressi e nei libri, proprio per il nostro impegno a elaborare le “tecniche”.
Che cos’è dunque una tecnica educativa?
In definitiva (ci si perdoni l’insistenza su questo punto) la tecnica non è altro che la realizzazione dei valori, i quali non esistono affatto “per sé”, come nell’iperuranio platonico, ma solo in quanto si attuano nella vita di scuola. Le tecniche sono così riscattate da una loro funzione meramente strumentale, alla quale vien subito da pensare data l’accezione corrente del termine. Esse non stanno al servizio di certi valori, ma sono i valori stessi. In quanto tali (ripetiamo), non sono adoperabili da chicchessia per finalità diverse; sono mezzo e fine al tempo stesso. O si accettano in questa loro unità sintetica, o si distruggono.
Esse […] sono i valori stessi
Ora ci si pone una domanda: perché parliamo di tecniche e non di “metodo”? Non è difficile rispondere, date le premesse che abbiamo posto. Il metodo, generalmente, designa un procedimento articolato, definito, compiuto, come se le finalità pedagogiche non dovessero realizzarsi se non attraverso quei precisi processi (come accade col metodo Montessori e altri) con quei precisi materiali. Ora, abbiamo detto che un fine, poniamo quello di formare attitudini al ragionamento critico, non si realizza che in una tecnica, o meglio, in alcune tecniche (che possono consistere, come vedremo, nel testo libero, nel calcolo vivente nella ricerca scientifica rettamente impostata). Non è assolutamente detto che non vi siano altre tecniche, oltre a quelle che noi consideriamo sperimentalmente valide, che possano promuovere l’attitudine critica. È per questo che noi parliamo di “tecniche”, al plurale, e non di metodo. Per questo noi parliamo di “apertura” verso ogni possibile nuova esperienza.
Perché, allora, (qualcuno potrebbe domandare ingenuamente) voi del Mce presentate alcune tecniche determinate, e non lasciate che ciascuno trovi la propria via personale? La domanda, l’ho detto, è ingenua. È ovvio, ormai, che ogni educatore deve percorrere una via propria, dettata da un insieme di condizioni; ma egli non può procedere affidandosi alle ispirazioni; ogni fine, anche puramente scolastico nel vecchio senso della parola, come l’insegnamento del leggere, dello scrivere e del far di conto, si raggiunge mediante processi che hanno una determinata “struttura”, frutto di innumerevoli esperienze via via superate e perfezionate. Insomma, la vita di scuola non è un vuoto fare, ma un operare in base a certe strutture, le quali non sono altro che le famose tecniche. Il maestro deve dunque partire dalle tecniche elaborate dall’esperienza didattica più moderna, non servendosene come strumenti o strutture che operano di per sé, magicamente, ma facendole proprie, cogliendone il significato intimo e perfezionandole creativamente. Noi, dunque, presentiamo certe tecniche, per tre ragioni fondamentali: 1) Per i valori di cui esse sono l’espressione, e che risulteranno chiari attraverso la loro particolareggiata esposizione. 2 ) Per la loro piena e profonda rispondenza alle disposizioni psicologiche dei fanciulli. 3) Per la loro sperimentata “adattabilità”a qualsiasi condizione o situazione oggettiva. Esse, infatti, non tendono a dar vita a esperimenti isolati, in condizioni speciali d’ambiente e di attrezzature, ma sono atte a rinnovare la vita didattica sia nel centro di una città come nell’ultima scuoletta di montagna. Ciò non significa che le tecniche siano incondizionate e non dipendano neanche parzialmente da condizioni oggettive. Significa solo che, in qualsiasi condizione, esse possano in una qualche misura operare un cambiamento. Le nostre tecniche, poi, non possono dar frutto in condizioni di chiusura e di isolamento. Esse presuppongono lo scambio e la cooperazione continua degli educatori e degli allievi di scuole diverse, di paesi diversi.
Tutti, nel mondo della pedagogia e della scuola, sembrano esser d’accordo sull’esigenza di “partire dal fanciullo”, di prendere atto dei suoi bisogni di base e dei suoi interessi, delle forze che si muovono in lui. Questa esigenza è agli occhi di tutti così ovvia e scontata che appare superfluo e tedioso metterla di nuovo in evidenza. La cosa, invece, non è poi tanto ovvia; l’accordo è nell’enunciazione verbale e non nel profondo delle convinzioni. In verità, purtroppo (parlo per la prima classe e le mie considerazioni valgono naturalmente anche per le successive) non si parte affatto dal fanciullo; il maestro, in vista del primo giorno di scuola, ha già pronto, se è diligente, tutto un suo programma di esercitazioni; ha in testa il suo “metodo” per l’apprendimento della lingua, globale o no, con tutti i suoi passaggi; ha pronti i cartelloni, magari le bustine col materiale più minuto. Dal primo istante in cui il fanciullo varca la soglia dell’aula il meccanismo, più o meno razionale, si mette in moto. Come vedremo, anche nei casi migliori il ragazzo diventa subito schiavo del “procedimento”; la sua vera personalità, la sua esperienza di vita è rimasta fuori, e probabilmente, se non entra in principio nella scuola, non vi entrerà più.
In questa prassi il maestro, armato di qualsiasi ideologia, sia pure agguerrito dalle migliori letture di psicologia, ha già perduto in partenza la sua partita; e non potrà mai saper niente del fanciullo che gli sta accanto. Potrà, sì, aver nozioni circa i suoi bisogni biologici di base e circa lo schema generale del suo sviluppo fisico e psichico; ma il suo alunno, il bimbo che dovrebbe diventar membro della sua comunità, non può essere considerato in maniera schematica e astratta; esso è un ragazzo che ha una storia particolare, che ha esigenze, attitudini, interessi, abiti, conoscenze, non dati da istinti o fattori biologici (non dati, come si dice, “dalla natura”), ma formatisi in un lungo, ricchissimo e intenso processo di vita. Il buon maestro deve mettersi al corrente delle ultime e più attendibili scoperte della psicologia scientifica; è questa una necessità imprescindibile; proprio in questi studi egli troverà lo stimolo e la preparazione basilare necessari per la sua opera. Ma egli, nel suo lavoro di scuola, dovrà farsi direttamente “psicologo”, sia pure non specializzato e di un genere particolare; dovrà prender atto delle strutture della personalità del suo ragazzo, già definite e consolidate:
dovrà, in una parola, accogliere tutta la ricchezza non misurabile che il fanciullo porta entro la comunità scolastica, e che non è verniciatura superficiale, imparaticcio che si dissolve in un dì, inutile ciarpame, ma cultura organica, profonda, sangue e carne del ragazzo.
Come prendere atto di questa realtà complessa che è il fanciullo? Il maestro dovrà prender contatto con le famiglie, studiare l’ambiente fisico e sociale in cui il ragazzo si è formato. Ma non è questa la via maestra. La realtà del fanciullo non risiede né nei suoi bisogni e nelle facoltà di base, astrattamente considerati, né, d’altro canto, nei fattori ambientali oggettivi che hanno agito su di lui. Il suo processo di crescita è frutto di un’interazione; non c’interessano i suoi “astratti bisogni”, ma il modo con cui sono stati socialmente condizionati e diretti; non c’interessa l’ambiente sociale in sé, ma il modo in cui è stato filtrato e assimilato dal fanciullo. Non c’è da andare lontano per cogliere la personalità del fanciullo, in tutta la sua ricchezza e concretezza. Basta che il ragazzo veda nella scuola il suo “ambiente di vita”, in cui egli non deve interrompere niente di quel che faceva prima, ma in cui anzi egli può giocare, drammatizzare, esprimersi in forma nuova e varia, sotto la guida del maestro che stimola e suggerisce. Basta che egli sia aiutato ad “aprirsi”, a comunicare; tutto quel che il fanciullo è, tutta la sua esperienza verrà fuori senza residui. Si tratta ora di vedere, sul piano didattico, come favorire e promuovere questa fecondità espressiva.
Ultimo aggiornamento: sabato 20 aprile 2023
Prima redazione: febbraio 2023
#valori, #coinvolgimento dei ragazzi, #tecniche didattiche, #principi, #grandi maestri, #carta studentesca, #Bruno Ciari, #regole, #Mario Lodi, #pedagogia, #cultura scolastica