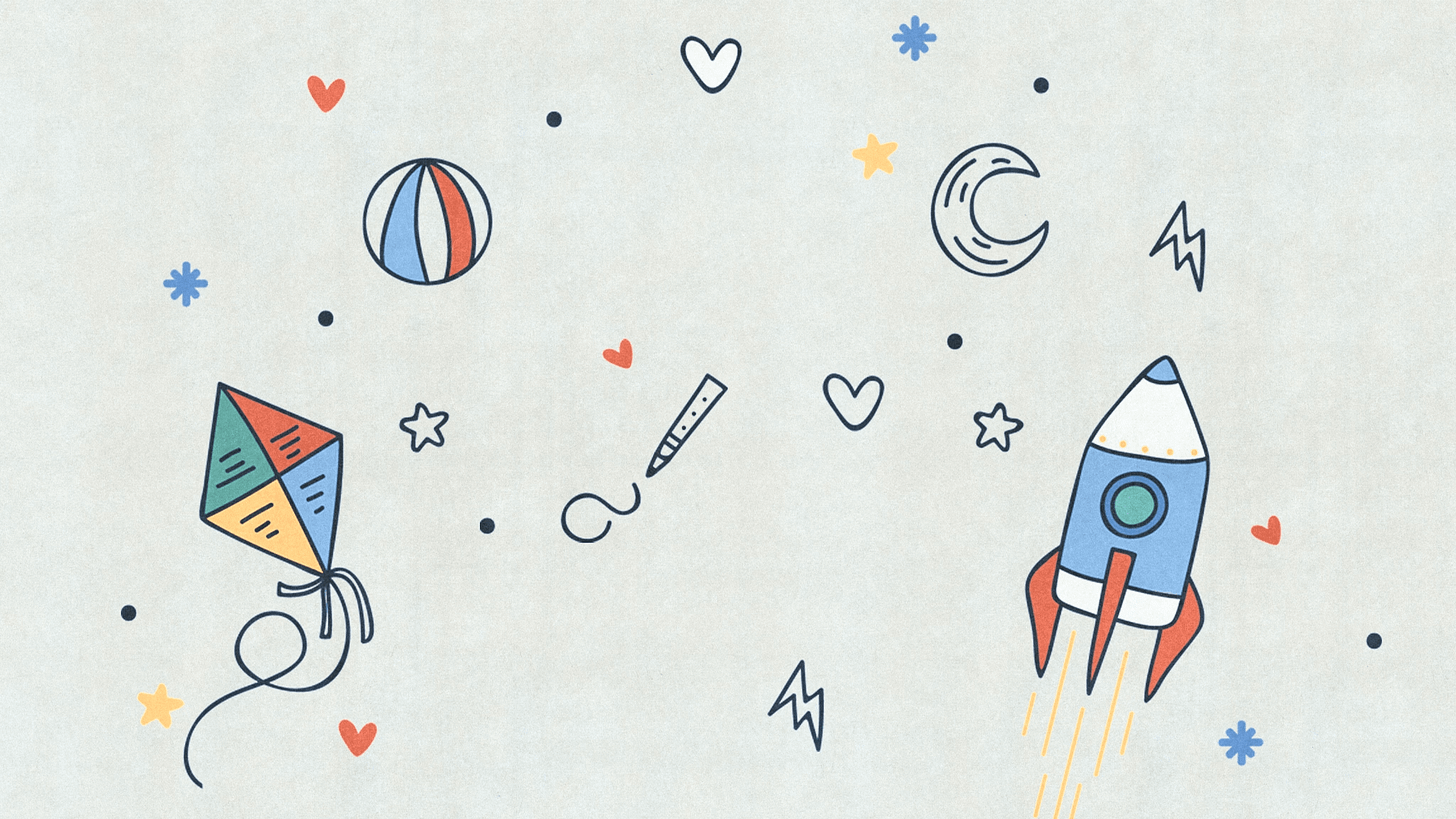«Scuola di fantasia» sarebbe tutto da sottolineare con l’evidenziatore. Edito da La Nave di Teseo nel 2020 riunisce una serie di testi scritti da Gianni Rodari a proposito di scuola, bambini, didattica ed educazione in generale.
Rodari fu giornalista e prosatore. La sua scrittura e la sua lingua sono la più bella espressione dell'italiano. I suoi testi sono chiari, diretti, semplici da capire. Non ho mai trovato nei libri che ho letto, frasi tanto splendide e ben costruite nei riguardi della scuola come in Rodari.
Le parole della fantasia
È infatti proprio a Reggio Emilia, tra il 6 e il 10 marzo 1972, che Gianni Rodari su invito del comune, organizzò una serie di incontri con insegnanti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie intitolato: Incontri con la Fantastica.
Rai Radio 3 nel 2020 ha pubblicato le registrazioni audio degli incontri con le maestre e gli educatori di Reggio Emilia del 1972. Per arricchire questo articolo dedicato a Rodari ve li propongo, tutti archiviati insieme, alla seguente pagina web: Le parole della fantasia – Audio
Note a margine
Ecco i punti salienti che più mi hanno colpito durante la lettura di "Scuola di fantasia" e sui quali mi ripropongo di ritornare più approfonditamente magari in qualche articolo per la rubrica "Note a margine"
Il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) ha applicato in Italia, con molta originalità, le “tecniche Freinet”: tipografia in classe, testo libero, calcolo vivente, lavoro a gruppi, lavoro libero, corrispondenza tra le classi, organizzazione cooperativa della comunità scolastica, eccetera. In una buona “classe MCE” la scala dei tradizionali “valori scolastici” – voto, pagella, interrogazione, disciplina, silenzio, emulazione individualistica, eccetera – ha perso, uno dopo l’altro, tutti i suoi tarlati gradini.
Si affermano altri valori: la collaborazione, la solidarietà, il piacere di lavorare insieme, l’atteggiamento di ricerca aperta su ogni aspetto del reale, la mentalità scientifica. Non si tratta di “espedienti”, ma di un metodo nuovo. Gli “espedienti” possono sempre essere usati contro il bambino: per ingannarlo, per mortificarlo e conformizzarlo; il “metodo” del MCE, mai.
Dalla scuola non potrei chiedere di più. Mi basta che essa possa insegnare al bambino a guardare e a criticare il mondo senza pregiudizi e senza paura.
Gli strumenti della tecnica entrati nella vita quotidiana per servirla, se ne impadroniscono. L’auto, il televisore, il frigorifero, la lavatrice, il giradischi sono idoli, ormai, più venerati e obbediti di qualsiasi altro nella storia delle religioni.
Le “piccole virtù” prendono il posto della “grande passione”, come in un matrimonio di convenienza. Le “grandi passioni” sono faticose: è facile stancarsene. Penso di descrivere(telegraficamente) un’esperienza abbastanza diffusa, di additare un pericolo che certo non siamo in pochi a vedere. Ecco, m’interessano soprattutto i suoi riflessi sul nostro rapporto coi figli. Se siamo noi a cedere, ad abbandonarci a una vita “senza passione”, a non provare rabbia per come va il mondo, a guarire dalla nausea, a rinunciare all’azione, possiamo ottenere due risultati, per noi ugualmente negativi: nel caso migliore(per loro) saranno i figli a rivoltarsi contro di noi, a fare contro di noi la loro “rivoluzione culturale”(speriamo che l’immagine non mi faccia qualificare come “cinese”); nel caso peggiore, alleveremo dei piccoli ipocriti carrieristi. Bravi tecnici, magari, ma odiosi “benpensanti”. E se noi non cediamo: se continuiamo a pensare che una vita “senza passione” è degna d’un albero, d’un gatto, ma non d’un uomo, allora come possiamo comunicare ai nostri figli questo atteggiamento? Sono sufficienti, allora, i consigli della psicologia e le conquiste della pedagogia sperimentale? Essere “genitori moderni” può bastare? Fino a che punto, e con quali mezzi, l’educazione del cuore deve accompagnarsi all’educazione della mente? Dovrei definire, prima d’andare avanti, che cosa intendo per “passione”. Sono sicuro d’averlo già fatto capire a sufficienza. Ma se occorre una definizione più precisa, eccola: intendo per “passione” la capacità di resistenza e di rivolta; l’intransigenza nel rifiuto del fariseismo, comunque mascherato; la volontà di azione e di dedizione; il coraggio di “sognare in grande”; la coscienza del dovere che abbiamo, come uomini, di cambiare il mondo in meglio, senza accontentarci dei mediocri cambiamenti di scena che lasciano tutto com’era prima: il coraggio di dire di no quand’è necessario, anche se dire di sì è più comodo, di non “fare come gli altri”, anche se per questo bisogna pagare un prezzo.
Rimane la necessità, il dovere, di comunicare loro non solo il piacere della vita, ma la “passione” della vita; di educarli non solo a dire la verità ma ad avere la “passione” della verità, eccetera. Vederli felici non ci può bastare. Dobbiamo vederli “appassionati” a ciò che fanno, a ciò che dicono, a ciò che vedono. Quando è, dunque, il momento di renderli non solo testimoni attenti(a questo ci pensano loro, anche se si fingono distratti) ma partecipi delle cose di questo mondo? E in che modo, partecipi? Con quali atteggiamenti di fondo? Ecco il punto.
Ma credo nell’efficacia educativa non già delle lacrime, quanto delle emozioni e commozioni che possono nascere dall’incontro con certi aspetti della realtà: con l’operaio che sciopera, per esempio, piuttosto che con il mendicante che tende la mano; con problemi che sollecitano una riflessione lunga e magari faticosa, invece che con scenette da “buona azione” quotidiana.
Ma l’esperienza non è necessariamente saggezza. Niente ci garantisce che noi non apparteniamo proprio a quella specie di persone che partono per il giro del mondo in un sacco e tornano a casa in un baule, senza imparare niente, imparando a spizzichi, a barlumi. Inoltre, questa benedetta esperienza, quando la consideriamo in veste di padri, ha la tendenza a presentarsi come un blocco di conquiste positive; forse, se fossimo un po’ più severi con noi stessi, la vedremmo meglio com’è: un blocco d’errori che cerchiamo di dimenticare. L’esperienza senza la critica del dubbio, poco giova a chi l’ha vissuta: figuriamoci se può servire a chi ne riceve solo la comunicazione verbale, come i figli dai padri.
L’umanità va avanti solo perché c’è continuamente chi mette in discussione la sua esperienza, le sue certezze. Altrimenti vivremmo ancora nelle caverne, perché nell’esperienza dei vecchi cavernicoli non c’è altro; e non ci sarebbe America, perché l’America non era nell’esperienza del mondo antico, è entrata nella storia perché Colombo è andato a cercare nuove esperienze oltre le Colonne d’Ercole; e nessuno avrebbe inventato la penicillina, nessuno avrebbe sperimentato i trapianti cardiaci, l’Italia sarebbe ancora quella del congresso di Vienna. Noi non possiamo pretendere di imporre la nostra esperienza ai figli, primo perché non ci riusciremmo, ed essi compirebbero le loro esperienze contro di noi; secondo perché il mondo non finisce con noi, non si ferma, non si congela. Possiamo–e questo sarebbe moltissimo–aiutare i figli a compiere le loro esperienze: ma per riuscirvi dobbiamo prima riuscire ad essere totalmente, profondamente solidali con loro, dobbiamo accettare che la loro esperienza corregga e critichi la nostra, dobbiamo–se possibile–imparare dalla loro esperienza più di quanto non imparino loro. È come dire che nei rapporti fra padri e figli, come in quelli tra la scuola e i giovani, niente di buono può nascere dall’autorità: tutto dalla solidarietà. Questo non significa sostituire all’autorità l’anarchia, come dicono le “guardie bianche” per paventare i buoni “sudisti”: significa sostituire all’autorità la solidarietà che è un’altra cosa.
Rovesciare il metodo Non è vero che i ragazzi non vogliono studiare. Non vogliono studiare come abbiamo studiato noi, ecco tutto.
Non esiste alcun motivo pedagogico psicologico comunque giustificabile, per imporre loro i vecchi modi di studiare: anzi, ne esistono di ottimi per rovesciare la scuola come una calza vecchia.
Se entriamo nella scuola, come genitori, per appoggiare i conservatori della scuola vecchia, noi agiamo contro i nostri figli, contro le loro esigenze di giovani, contro i loro interessi di giovani. Ci possiamo, e ci dobbiamo, entrare per aiutare insegnanti e studenti a creare insieme una scuola diversa. Allora facciamo cosa utile ai nostri figli, anche se ci vorrà un po’ perché lo ammettano, diffidenti come sono ormai, per colpa nostra, nei nostri confronti. Ci possiamo e ci dobbiamo entrare non per gridare, stupidamente “Disciplina! Disciplina!”, ma per cercare insieme noi e loro, genitori e professori e studenti, la strada nuova; per mettere in discussione, con la modestia, la pazienza, la tenacia, la tolleranza, che sono i mezzi della democrazia per aiutare insieme la ragione a maturare e a prevalere sulla prepotenza, l’ignoranza, lo spirito di sopraffazione, lo spirito di conservazione, il privilegio(che è la causa prima del disordine).
Le forme del mondo cambiano. Come, in che misura e in che senso, questi cambiamenti influiscono sul mio modo di crescere, sul modo e sul processo con cui mi faccio un’immagine del mondo e concepisco il mio posto in questo mondo? Ecco un problema che mi interessa, e sul quale–come mi riferiscono persone da me appositamente consultate–non esiste ancora una sufficiente letteratura.
Bisogna diffidare di tutte le deplorazioni del tempo presente, dei suoi disagi e delle sue crisi, nelle quali sia avvertibile in qualche modo, sotto una qualsiasi maschera, il rimpianto del passato. Si tratta, quasi sempre, di un rimpianto “di classe”, quando non è un semplice effetto secondario del processo di invecchiamento, e allora è–ne ho parlato altre volte–non un rimpianto di tempi migliori, ma della propria giovinezza. Bisogna guardarsi dal coltivare rimpianti del genere, se si vuole avere qualche possibilità di capire i figli, se si vuole stare dalla loro parte, se si aspira ad aiutarli.
Applicazioni del modello “Un tempo la scuola era più seria”. Non è vero: era fondamentalmente meno seria perché accettava senza discutere di essere la scuola dei privilegiati e lasciava fuori dalle sue pareti, senza il minimo rimorso, la grande maggioranza dei ragazzi. Era meno seria perché vegetava nella piccola provincia pedagogica italiana senza accorgersi di quel che bolliva nella pentola scolastica nel resto del mondo. Era così poco seria che nella classe elementare descritta dal Cuore di De Amicis il maestro dava del voi ai figli dei signori e del tu ai figli degli operai.
I ragazzi non possono assolutamente guardare al passato, perché non hanno un passato. Quello dei loro genitori non li riguarda: è una favola lontana. Prima di loro il mondo non è mai esistito, non ha mai offerto termini di paragone. Essi possono soltanto paragonare il reale al possibile che riescono a immaginare, l’oggi alle loro speranze, le cose che vedono alle cose cui aspirano. Non si riesce a parlare con loro se non si accetta questo punto di vista come punto di partenza.
Che cosa è questo libro che si intitola, metà sul serio e metà per scherzo, Grammatica della fantasia? È un’offerta di strumenti per contribuire a creare nella scuola un ruolo nuovo al bambino, un ruolo di un bambino creatore, produttore, ricercatore, invece del tradizionale ruolo passivo che il bambino ha sempre avuto nella scuola.
La scuola tradizionale ha sempre puntato su due qualità di fondo, su due virtù scolastiche: l’attenzione e la memoria;“stai bene attento a quello che ti dico e studia bene per ripetere quello che ti dico”, questa era la scuola dalla prima elementare all’ultimo anno di università. Mi sembra che oggi occorra invece una certa analisi di altre funzioni della mente e della personalità infantile: per esempio della creatività, dell’immaginazione; un’analisi dell’immaginazione e dei suoi meccanismi che sono uguali nel bambino e nell’adulto, nell’artista e nel falegname. La fantasia che crea, l’immaginazione produttiva, non è un privilegio di alcune persone che sono nate con un “registro” in più, con una tastiera più ampia di altre, sono cose che fanno parte della personalità di tutti gli uomini, anche se non tutti gli uomini sono messi in condizione di sviluppare, di estendere questa loro capacità: non solo nel senso di riprodurre il reale per viverci in mezzo(lo devono comunque riprodurre), ma anche di produrre cose nuove, di scoprire nuovi problemi.
Una parola può generare una storia perché mette in movimento tratti della nostra esperienza, del nostro vocabolario, tratti del nostro inconscio, mette in movimento le nostre idee, la nostra ideologia. Da qualsiasi punto noi partiamo per inventare una storia, una storia apparentemente astratta, in quella storia entrano tutti i nostri contenuti, questo ho cercato di dimostrare. Tutta la personalità è impegnata anche quando si parte da quello che io ho chiamato “binomio fantastico”
La fantasia non è in opposizione alla realtà, è uno strumento per conoscere la realtà, è uno strumento da dominare. L’immaginazione serve per fare ipotesi e di fare ipotesi ha bisogno anche lo scienziato, ha bisogno anche il matematico che fa dimostrazioni per assurdo. La fantasia serve per esplorare la realtà, per esempio per esplorare il linguaggio, per esplorare tutte le sue possibilità, per vedere cosa viene fuori quando si fanno scontrare le parole.
Non posso fare storia senza la lingua, non posso fare filosofia senza la lingua, non posso fare politica senza la lingua, non posso vivere senza la lingua. Noi siamo nella lingua come il pesce è nell’acqua, non come il nuotatore. Il nuotatore può tuffarsi e uscire, ma il pesce no, il pesce ci deve stare dentro. Così siamo noi dentro la lingua: la parliamo e qualche volta ne siamo anche parlati. È la lingua che parla per mezzo nostro con i luoghi comuni, con i modelli precostituiti, con le parole che abbiamo ricevuto in eredità, con i concetti che abbiamo assorbito, con tutto quello che parla per mezzo nostro ma non è pensiero nostro: quando diciamo le cose che ci vengono dal mondo o dalla TV o dal giornale, la lingua parla attraverso di noi ma non sempre siamo noi che parliamo. Noi dalla lingua non possiamo uscire e io credo che bisogna sapere e capire questo per capire che in ogni sua attività il bambino impegna sempre tutta la sua personalità con le sue varie funzioni: le impegna tutte, quella che immagina e quella che osserva, classifica, misura.
Ora io credo che tutta la scuola di ogni ordine e grado debba ormai basarsi su una idea di ciò che è conoscenza diversa da quella del passato. Dicevamo prima: la scuola dell’attenzione e della memoria ha fatto il suo tempo, occorre una scuola in cui entri la creatività e l’immaginazione(del bambino, del ragazzo, del giovane). Prendiamo il discorso stesso delle “basi”, il famoso discorso che spesso i genitori fanno agli insegnanti di avanguardia o qualche volta gli insegnanti tradizionalisti fanno agli insegnanti più innovatori:“Ma bisogna pure che diamo le basi”. Che cosa sono queste basi? Ecco, una volta potevano essere intese come delle piccole quantità, ai tempi di Dante era pensabile che un uomo solo dominasse tutto il sapere del suo tempo e Dante, come si vede dalla sua Commedia, conosceva tutto quello che si sapeva al suo tempo di lettere, di geometria, di teologia, di astronomia, di astrologia, di fisiologia umana, conosceva tutto quello che si poteva sapere del suo tempo, ma appena qualche secolo dopo per fare l’enciclopedia i francesi ci si sono dovuti mettere in decine perché non esisteva già più l’uomo che da solo poteva dominare tutto il sapere del suo tempo. E se voi date una occhiata oggi a un’enciclopedia, anche di quelle confezionate solo per la vendita, voi vi accorgete che campo sterminato sia oggi quello della conoscenza umana, nascono continuamente nuovi campi perché la storia produce nuovi settori da esplorare. Cinquant’anni fa l’idea di una “astrobotanica” per esempio(di astrofisica ce ne siamo già occupati), come anche di astromedicina, di medicina spaziale era impensabile. Ecco, nascono continuamente nuovi campi di quello che noi chiamiamo sapere e questo oceano diventa sempre più grande. Se noi intendiamo “le basi” che la scuola deve consegnare al bambino, al giovane, al ragazzo, in senso quantitativo, noi ci mettiamo nella condizione di quel bambino descritto da Sant’Agostino mentre sta tentando di vuotare l’oceano con un secchiello. Lo stesso è la nostra scuola che dà al bambino un pochino di aritmetica, un pochino di geografia, un pochino di storia. Gli dà dei secchielli di questo oceano, ma queste non sono più“basi” oggi. Oggi le basi non devono più essere quantitative, devono essere qualitative, cioè al bambino noi non possiamo consegnare l’oceano un secchiello alla volta, però gli possiamo insegnare a nuotare nell’oceano e allora andrà fin dove le sue forze lo porteranno, poi inventerà una barca e navigherà con la barca, poi con la nave… Dobbiamo cioè consegnare degli strumenti culturali. La conoscenza non è una quantità, è una ricerca. Non dobbiamo dare ai bambini delle quantità di sapere ma degli strumenti per ricercare, degli strumenti culturali perché lui crei, spinga la sua ricerca fin dove può; poi certamente toccherà sempre a noi spingere più in là e aiutarlo ad affinare questi strumenti.
È vero che nella scuola elementare c’è una larga e acuta sperimentazione, vi cito solo il Movimento di Cooperazione Educativa che da anni–e certamente anche da prima dei Comuni emiliani–ha cominciato a battere una strada nuova e su questa strada è andato molto avanti. È anche vero però che questo movimento non dispone del potere realizzatore di cui dispongono invece i Comuni quando si attivano nei confronti del problema della scuola. Quindi le loro realizzazioni sono un poco ristrette. Non le voglio chiamare in senso dispregiativo “isole felici” come è stato fatto, io non sono d’accordo, rifiuto questa definizione che è offensiva. Non sono isole felici, sono felici quei bambini che ci stanno dentro e questo va bene, ma non sono isole felici nel senso che abbiano fabbricato cose che sono vere lì e non sono vere altrove, quella non è la scuola di Don Milani che era unicamente legata alla persona di Don Milani. Questa scuola, quella dei Ciari, quella dei Mario Lodi, quella del Movimento di Cooperazione Educativa è una scuola che fabbrica strumenti validi per tutti e non solo per la scuola elementare ma anche per la scuola media, anche per la scuola secondaria superiore quando se ne accorgerà, quando avrà anche l’umiltà di curvarsi sul lavoro di questi maestri che son dei grandi iniziatori, non dei piccoli, ma dei grandi iniziatori.
Ma io mi riferisco anche, parlando di qualità, alla continua ricerca pedagogica, alla continua riscoperta del bambino, al continuo rimettere in discussione anche quello che si è fatto e si è provato perché non ci si può fermare, perché il ragionamento non è mai conquistato una volta per tutte, perché ogni bambino, ogni classe, ogni annata, ogni generazione, crea problemi nuovi e vanno affrontati anche in modo nuovo.
La scuola nuova deve crescere nella scuola vecchia come un pulcino cresce dentro l’uovo. Questa scuola può nascere, se si dimostra con i fatti che è possibile, e io credo che anche la vostra scuola dell’infanzia dimostri che è possibile un’altra scuola. Nasce se si convince la gente, il popolo, le masse, con l’azione, che è possibile. […]
Il parlare per gioco non è meno importante del parlare sul serio soprattutto in un’età in cui il gioco è uno dei mezzi essenziali con cui il bambino stabilisce i suoi rapporti con gli altri, con l’ambiente e con la realtà. Il gioco non lasciamolo passare in seconda linea di fronte ad altre attività perché è importante quanto le altre attività, è collegato con tutte le altre attività. Il parlare per ridere, per inventare, per sfogare la propria aggressività, serve a metter fuori contenuti repressi, ad aprire delle valvole(e già questo sarebbe importante), ma gli serve soprattutto per sentirsi libero o per trovare in se stesso la forza e l’impulso ad agire, a imparare, a scoprire, a misurarsi con la realtà, ad andare avanti, a crescere. Dobbiamo liberarci dall’idea che la formazione mentale, culturale, morale del bambino venga da quello che sa di grammatica, di geografia o da tutte quelle cose che gli possiamo dire noi. Dipende da quello che lui sa fare, da quello che lui sa conquistare. Io so a memoria le poesie che ho amato e che nel corso di tanti anni ho continuato a leggere finché mi si sono fissate da sole nella memoria senza che io avessi mai cercato di studiarle a memoria. Quelle che ho studiato a memoria, a scuola, per la scuola, perché era compito lo studiarle a memoria, quelle le ho dimenticate; così è, credo, di tutte le altre cose. Ognuno sa quello che ha fatto, quello che è stato stimolato a fare liberamente. Stiamo dunque attenti a non subordinare in nessun modo le attività della scuola dell’infanzia al modello tradizionale, non dico soltanto della scuola dell’infanzia ma della scuola elementare. […]
Ci sono regole non scritte, non codificate, che tutti dobbiamo, insieme, fare nostre. La prima è di sapersi ascoltare. Abbiamo sempre troppa fretta di scavalcare le persone per arrivare allo schema che le rappresenta. Chi è quello che parla? Un reazionario. Un estremista. Un incolto. Un esibizionista. Un democristiano. Un liberale. Un idealista. Eccetera. L’etichetta ci serve per anticipare le sue conclusioni, per schematizzare il suo discorso. E così ci vietiamo di capire se in ciò che sta dicendo c’è o non c’è, in modo indiretto e distorto, qualcosa che può essere vero e utile anche per noi.
Un’altra regola è quella di saper parlare. Parlare di cose, di problemi, di oggetti, senza personalismi, senza esibizionismi. Parlare per dire, non per ascoltarsi. Parlare per comunicare, non per sfogarsi. Parlare per cercare, non per auto-affermarsi, non per proclamare. Più difficile, ma ugualmente necessario, è nell’incontro o nella discussione non cercare la vittoria, ma l’intesa, la decisione possibile e opportuna. Discutere per avere assolutamente, sempre e su ogni punto, completa ragione, è puerile. Porta al cavillo(il gusto tutto italiano del cavillo… siamo tutti avvocati). Per l’insegnante, si tratta di accettare serenamente una fatica in più, che cambia il suo ruolo, ma non per ridimensionarlo, bensì per nobilitarlo: l’insegnante che diventa un animatore culturale e sociale è qualcosa di più del piccolo padrone di un registro su cui segnare voti. Per il genitore, si tratta di capire che nell’incontro, se la partita è di dare ed avere, l’insegnante deve dare più di quello che riceve, perché è lui che deve compiere le rinunce meno agevoli: il genitore ha conquistato un diritto, l’insegnante può vivere la nuova situazione come una perdita di potere(naturalmente non è così per gli insegnanti che non tengono al loro piccolo potere; ma sono molti?). Per gli uni e per gli altri si tratta di mettersi alla pari. E di mettersi alla pari con gli studenti. Di superare i ruoli tradizionali–genitore, insegnante, studente–per assumerne uno nuovo, di protagonisti della riforma della scuola.
Ci fidiamo delle “grandi linee” che ci descrivono gli studiosi di psicologia dell’età evolutiva, non sempre attendibili, perché pochi di loro lavorano dal vero, molti non fanno che scriversi l’uno addosso all’altro, in una permanente trasmissione di conoscenze libresche. Un bambino, ogni bambino, bisognerebbe accettarlo come un fatto nuovo, con il quale il mondo ricomincia ogni volta da capo. Questa è la cosa principale che dovrebbero insegnare ai genitori i manuali per l’educazione in famiglia, e ai maestri i trattati di pedagogia e di didattica.
Solo una disposizione del genere può giustificare poi tutti i discorsi che si fanno sui “diritti del bambino”, sulla “scuola su misura del bambino”, sul bambino “produttore” e “creatore”, anziché consumatore(di sapere, di cultura, di valori). Altrimenti sono un inganno. I “diritti del bambino”, a parte quelli primari ed elementari(il diritto alla casa, all’infanzia, al gioco, alla scuola) non possono essere fissati una volta per sempre: bisogna accettare che siano i bambini stessi ad affermare, a precisare, a rendere concreti ed attuali i loro diritti. La “scuola su misura” non può essere descritta una volta per sempre, in un modello da realizzare e ripetere: può nascere solo come scuola che rinnova continuamente il suo modello, interpretando sempre di nuovo le esigenze, i suggerimenti diretti o indiretti, la cultura spontanea, i bisogni di quei dati bambini, di quel dato bambino, in quell’anno, in quel giorno. Una fatica terribile: ma la sola necessaria. Genitori e maestri possono essere utili al bambino solo se sono pronti a rinnovarsi continuamente, ad adattarsi alla sua crescita, a mettere in discussione il proprio bagaglio culturale e tecnico, la propria idea del mondo.
Il concreto, nell’educazione, è il bambino: non il progetto educativo, non il programma scolastico, non la tecnica didattica in sé. Sono cose banali, ma ce ne dimentichiamo ad ogni passo, perché ci fa comodo, perché l’idea che la rieducazione continua dell’adulto sia la premessa di ogni attività educativa è difficile da accettare nella pratica. Essa genera l’impressione che non esistano punti fermi. La sensazione di una scala che sale soltanto, senza possibilità di scendere, senza pianerottoli per riposare. Ma questa è la vita, se non vogliamo illuderci: un lavoro da cui non si può andare in pensione, se non con la fine.
Tutto questo potrebbe venire scambiato per un discorso sullo spontaneismo. Invece è proprio il contrario. Chi punta sullo spontaneismo non si preoccupa di aiutare il bambino: gli basta lasciarlo fare, vada dove vada. Puntare sul bambino è diverso, impone attenzione, spirito di servizio, impegno costante a essere, per lui, le cento cose di cui ha bisogno: il compagno di crescita, di gioco e di scoperta, l’animatore, l’esperto, il potere che gli procura gli strumenti che gli servono, l’adulto che lo provoca, gli rivela nuovi orizzonti, nuove direzioni di movimento. Noi siamo i gradini della scala che il bambino sale. Non c’è niente di mistico, in questo. Di fatto siamo quei gradini anche quando non ce ne accorgiamo: allora, s’intende, siamo gradini sconnessi, pericolanti e pericolosi.
In un’impresa educativa il programma non dovrebbe essere l’elenco delle cose che ci proponiamo di ottenere dai bambini, ma di quelle che dobbiamo fare noi per essere utili ai bambini. Dovremmo elaborare regole per il nostro comportamento, non per quello dei bambini: i quali, se messi in condizione di farlo, sanno benissimo inventarsi le loro regole, quelle di cui hanno veramente bisogno, e rispettarle. Basta guardarli giocare, cioè muoversi all’interno di regole liberamente scelte, liberamente accettate, e accettate non perché fanno piacere a noi, ma perché fanno piacere a loro. I bambini non dovrebbero fare niente perché sono costretti, o perché vogliono piacerci, o perché ci vogliono bene, o perché hanno paura di noi.
Nella realtà, come i personaggi delle favole, essi crescono tra una selva di ordini e di divieti, di “fa questo” e “non fare quello”. Anche a scuola, come ha descritto molto bene Giorgio Testa su questo giornale, 1 ci vanno perché ci sono mandati. È una contraddizione che si può risolvere solo trasformando la scuola in un luogo dove sono contenti di andare: in attesa che il futuro immagini altre vie dell’istruzione pubblica. Detto così, è molto banale: ma forse non c’è un modo più onesto di dirlo. L’idea che la scuola debba servire ad addestrare i bambini alla fatica è un alibi pericoloso offerto a chi vuole evitare ogni cambiamento. In realtà i bambini sono capacissimi di fatica, di sforzi continuati, diretti a una meta: basta vederli giocare al pallone fino a quando cadono spossati, sudati e felici; o vivere e lavorare in un campeggio; o progettare una costruzione e realizzarla. Se il progetto è loro, è nato da loro, in loro, la fatica non li spaventa: e a scuola ci tornano anche volontari, dopo le ore di lezione, come ci ha mostrato e dimostrato tante volte il compianto Bruno Ciari. All’educazione, in casa e a scuola, bisogna avere il coraggio di pensare senza guardarsi indietro, senza pretendere di vedere in avanti, ma, per così dire, in presa diretta con i bambini e con la loro volontà di crescere.