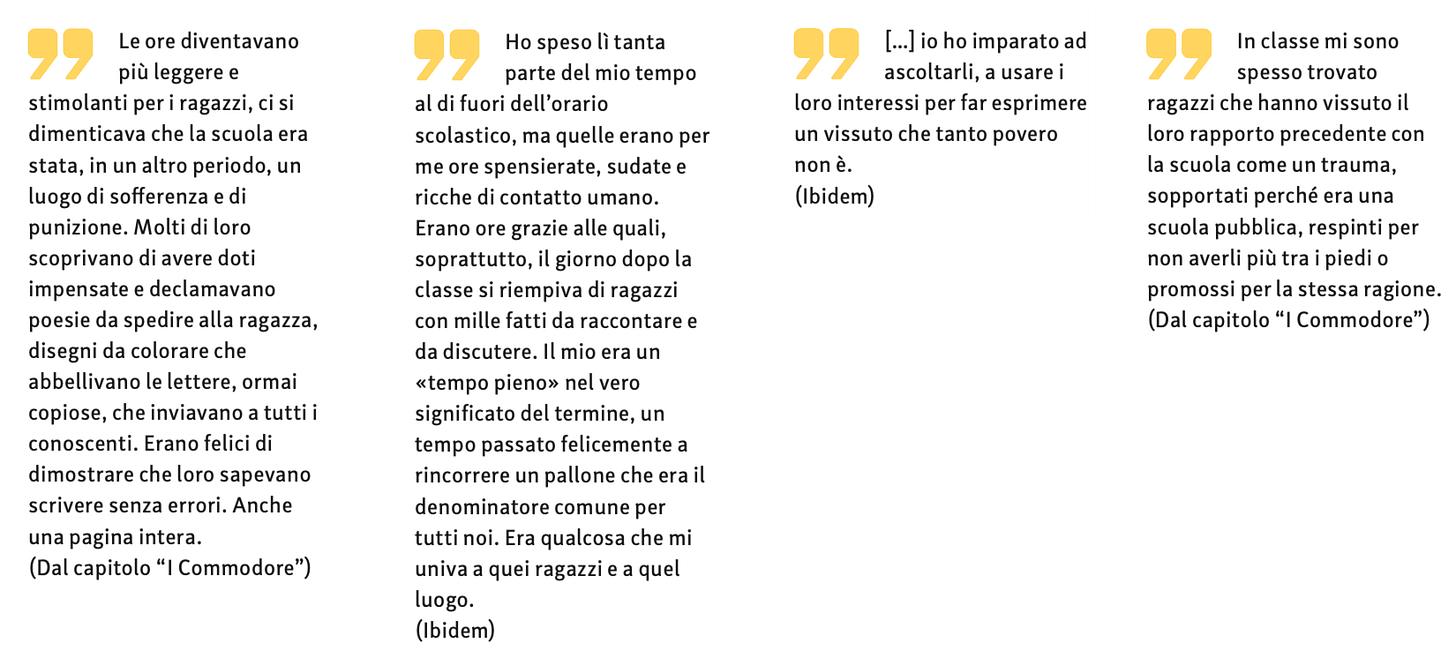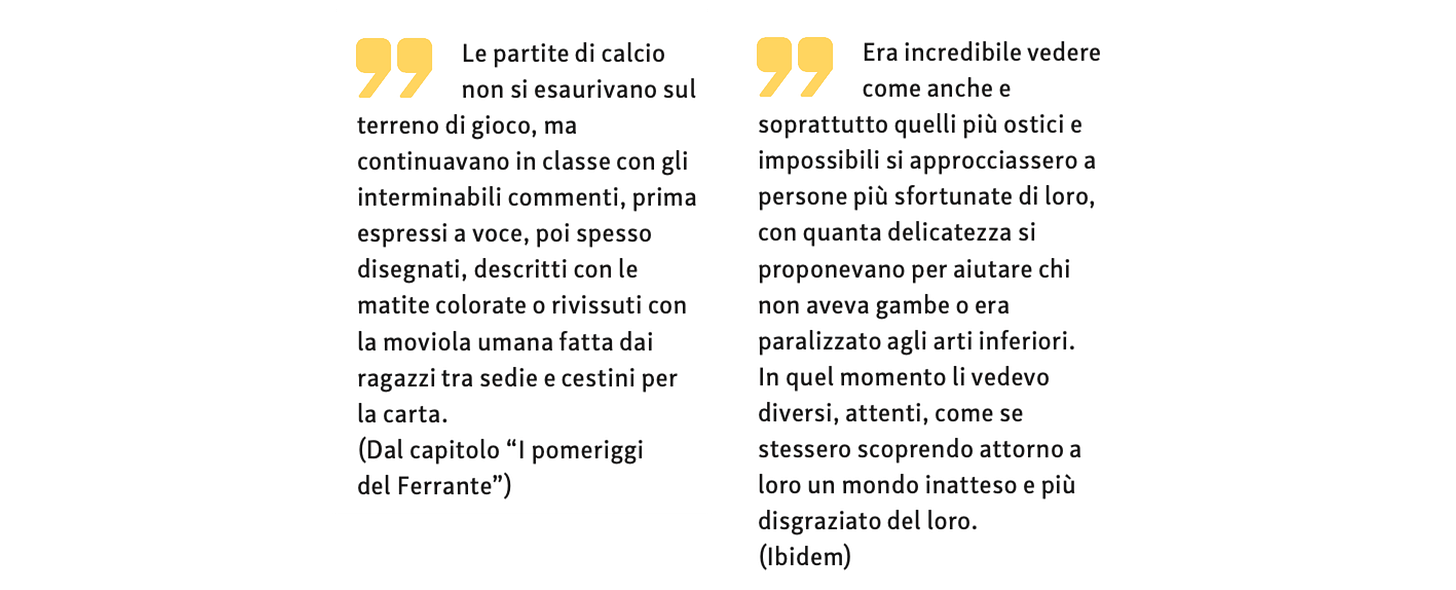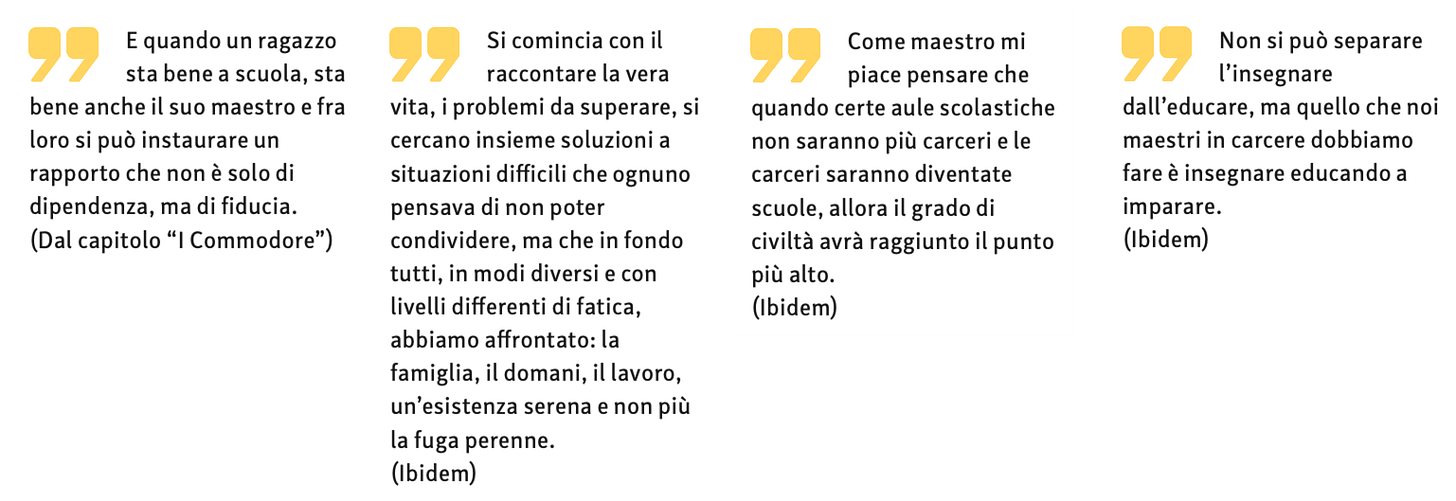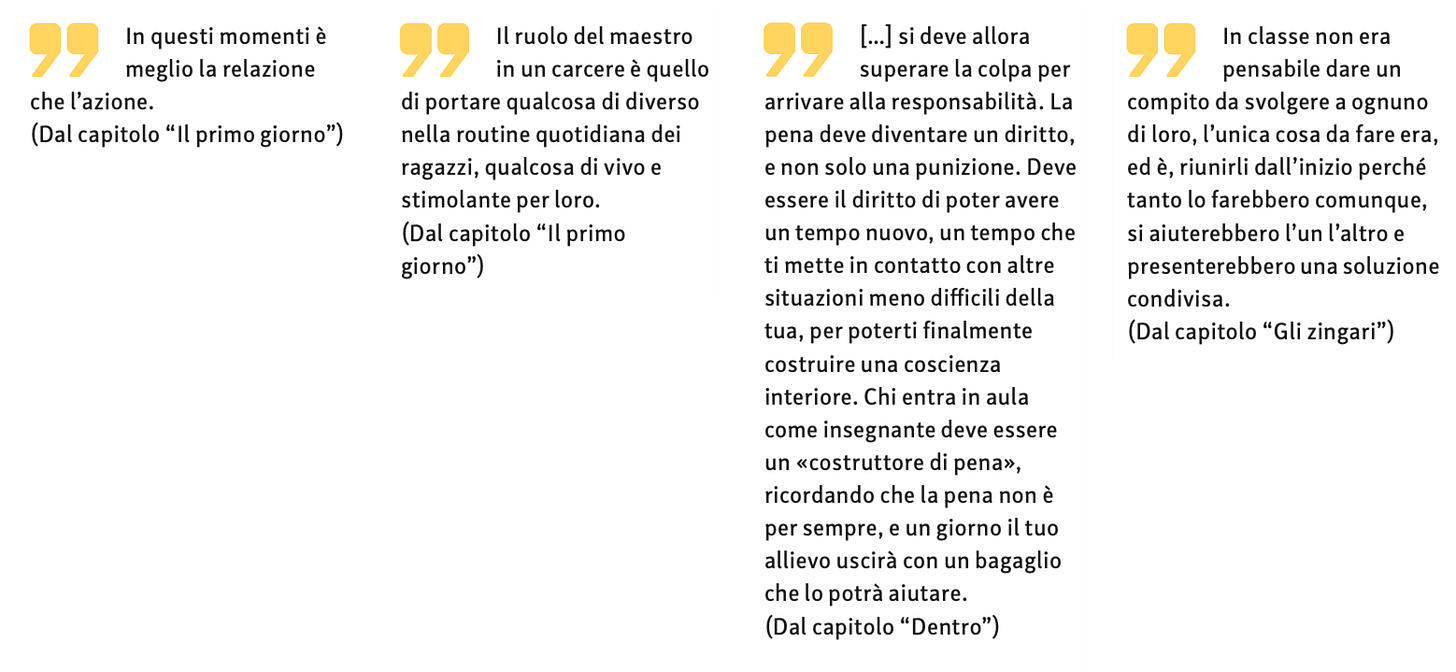“Il maestro dentro”, questo è il titolo del libro di Mario Tagliani. Il sottotitolo è più esplicito “Trent’anni tra i banchi di un carcere minorile” (Add Editore, 2014).
È un maestro speciale, molto speciale, l’unico maestro dei suoi studenti. Un maestro senza collegi docenti né scrutini, niente voti, né giudizi. Un vero maestro nella progettazione di lezioni personalizzate, inclusive e coinvolgenti.
Tutte le citazioni riportate, se non diversamente indicato, sono tratte dal libro sopra menzionato.
Nelle sue parole e nel suo operato ho potuto prima leggere e poi imparare e ascoltare, dalla sua viva voce: la forza, l’entusiasmo, la speranza, la fiducia, la perseveranza e la costanza, l’amore, la dedizione. E ancora: i passi insieme, gli abbracci di gruppo, le lezioni corali, le partite a calcio, i pranzi in compagnia, le visite nelle case e nelle comunità degli studenti, le esplorazioni insieme ai ragazzi divenuti uomini, la condivisione delle esperienze di vita, le emozioni esperite e molto altro. Le parole non bastano a descrivere ciò che si può solo sentire col cuore.
Ecco l’intervista redatta durante il 2020, in piena pandemia, a distanza.
L'intervista
Se è vero che, come lei dice, «programmi “normali” hanno creato dei devianti», e che, «bisogna avere il coraggio di sviluppare modelli di apprendimento “diversi”», mi sveli qual è il segreto per sviluppare dei modelli di apprendimento diversi? Possono esistere dei modelli?
«Non possono esistere modelli perché non esiste un ragazzo uguale ad un altro. Ecco perché una programmazione che cala dall’alto può creare dei “devianti”. Quando i miei ragazzi a 6 anni si sono affacciati a scuola hanno provato subito cos’è il divario culturale, ed il disagio che hanno provato li ha portati a rifiutare una istruzione che non sentivano adeguata. Quando le due grandi agenzie formative, la famiglia e la scuola, cedono al loro dovere ecco che si crea il “deviante” che cerca altre strade per affermarsi. Se la famiglia non è stata in grado di assolvere al suo compito dovrebbe essere la scuola, ultimo baluardo, a sviluppare apprendimenti diversi, calibrati sulle competenze di ognuno. Lo so che nella scuola “normale” è difficile, ma se non lo facciamo spesso quel ragazzo svogliato, distratto, disinteressato, seguirà altre strade, molte delle quali lo porteranno in carcere. La fortuna della mia classe, negli ultimi anni, stava nel numero esiguo di allievi (7 o 8), anche se gli avvicendamenti erano frequenti. Di ogni ragazzo io conoscevo la storia, le abitudini, i sogni e le potenzialità, ma spesso il danno che avevano subito era irreversibile. Tutti erano convinti che l’istruzione non era una priorità, quindi il mio compito, prima di sedersi al banco, era di fargli amare quell’aula scolastica che avevano sempre vissuto come un luogo di disagio, di sofferenza e di noia. Le canzoni rap al posto del tema, i giochi matematici, la geografia attraverso il calcio, la storia di ognuno che diventava la storia dell’uomo erano tutti apprendimenti “diversi” che mantenevano viva l’attenzione e spesso erano fonte di altre domande e precisazioni. Sto pensando che paradossalmente la più ampia libertà di insegnamento sta chiusa dentro l’aula di un carcere!»
Maestro che valore ha per te l’ascolto?
«Sta scritto nella prima pagina del libro, liberamente interpretando una frase di Simon Weil: l’ascolto è la più alta forma di altruismo. Ma non solo: senza l’ascolto non avrei mai saputo cosa fare in aula con i miei ragazzi.»
Maestro secondo la tua trentennale esperienza di insegnante, in che rapporto stanno tra loro la scuola, l’aula, il lavoro e la formazione professionale? “Stanno” ti sembra il verbo giusto?
«È un rapporto dinamico, elastico. Non esiste il metodo per insegnare, né come tenere insieme ragazzi provenienti da ogni parte del mondo; non esiste il lavoro perfetto ma deve esistere la capacità di saper leggere le situazioni contingenti per affrontare la vita con cognizione di causa. Per questo i ragazzi prima devono andare a scuola, perché a scuola si fanno incontri e dagli incontri impariamo a stare con altre persone. La scuola non è la vita ma non è nemmeno un gioco; ma se una situazione prima difficile adesso è diventata piacevole, allora possiamo continuare anche sul versante della formazione professionale allo stesso modo. Nessuno di noi sa cosa ci riserverà il futuro, nemmeno io sapevo che avrei scelto di fare il maestro, ma se abbiamo imparato a guardarci dentro troveremo la nostra strada con entusiasmo. In questo senso penso che la scuola e il lavoro possano “stare” in rapporto.»
Maestro quali sono gli ingredienti che a tuo avviso preparano i ragazzi al cammino che li attende fuori e nel futuro? O, per dirla con le tue parole, cosa serve per «accompagnare la loro crescita»?
«Una casa è fatta di tanti mattoni, la crescita deve avvenire per gradi e secondo le proprie possibilità. Quando queste mancano ecco che bisogna intervenire e questo lo scopriamo solo se siamo buoni ascoltatori.»
Maestro, quando nel tuo libro parli dei tuoi rom, spieghi anche che era impensabile «dare un compito da svolgere a ognuno di loro» senza che si aiutassero e presentassero una «soluzione condivisa»..
Tu come hai fatto scuola con chi come loro condivide sempre? Qual è la tua metodologia didattica in questi casi? Quali sono state le tue proposte per loro?
E poi secondo la tua lunga esperienza, come si riesce a fare inclusione quando i ragazzi sono tutti unici e diversi tra loro?
«Il mondo dei rom è proprio un altro mondo. Per capirlo a fondo bisogna vivere con loro accettando anche regole non certo condivise. Il mio compito era di trovare uno stimolo per farli venire in aula e attirare la loro attenzione e fiducia. La lingua scritta non appartiene al mondo dei nomadi e così con loro si leggeva spesso di viaggi e avventure, di tesori e di feste, di musica e di tradizioni. Sono stati poi loro a chiedermi di imparare a scrivere perché avevano capito che saper scrivere apriva altri mondi sconosciuti. La peculiarità di un gruppo rom era che se uno imparava una lettera, una frase o un’operazione aritmetica, subito la condivideva, a modo suo, con gli altri quasi ad affermare una supremazia simile a quella che secondo loro ti dà il denaro. La storia di questo popolo, che è abituato alla sofferenza da sempre, penso sia arrivata ad un bivio: non essendoci più le condizioni per uno stile di vita legale (commercio di cavalli, spettacoli viaggianti, produzione e riparazione di attrezzi agricoli, produzione di oggetti in rame e stagno ecc.) dovrà sedentarizzarsi o non rimarrà che il commercio illegale e il furto.»
Maestro, tu come hai portato e continuato a portare «qualcosa di vivo e stimolante per loro» nella routine e nella vita dei tuoi ragazzi?
«Se pensiamo a quante possibilità abbiamo oggi di conoscere il mondo stando seduti a casa dopo la rivoluzione di internet, allora certo gli stimoli non mancano. Dobbiamo pensare che la restrizione in un carcere significa essere privato non solo della libertà di movimento ma anche di tutte quelle possibilità di conoscere il mondo. Penso agli anni ‘80 quando i ragazzi si vergognavano a scrivere con una penna per timore di essere derisi, e allora introdussi il computer in aula come mezzo per scrivere; penso alla musica, ai film, allo sport ecc., tutte occasioni per discutere, per dare a tutti il giusto tempo di intervento e di attenzione; penso a quante gare nello scrivere canzoni rap che parlavano di loro e dei loro sogni; ai giochi di matematica per far capire quanto siano importanti i numeri. Se ci guardiamo attorno e pensiamo a quanto manca dentro un aula del carcere, allora non è difficile trovare occasioni per imparare tutti assieme.»
Cosa offre, secondo te, lo sport ai ragazzi?
«A quell’età lo sport è fondamentale non solo perché li mette insieme ma perché serve a scaricare quegli ormoni che prepotentemente si affacciano in superficie. Sono convinto che se i ragazzi di un carcere tutto il pomeriggio facessero sport, naturalmente organizzato e strutturato da un adulto, non assisteremmo a quegli odiosi episodi di bullismo e prevaricazione che avvengono nelle celle.
C’è un passo di un discorso rivolto ai ragazzi, pronunciato nel 2017 in occasione di un evento di preparazione alla giornata mondiale della gioventù, da Papa Francesco. Questo passo rivolto ai ragazzi mi è molto caro, e mi ci ritrovo spesso a ragionare.
Ci vuole coraggio. E cercare di cogliere la bellezza nelle piccole cose, come ha detto Pompeo, quella bellezza di tutti i giorni: coglierla, non perdere questo. E ringraziare per quello che sei: “Io sono così: grazie!”. Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti chi sei e trascorre una vita intera cercando chi sei. Ma domandati: “Per chi sono io?”. […] Come la Madonna, che è stata capace di domandarsi: “Per chi, per quale persona sono io, in questo momento? Per mia cugina”, ed è andata. […] Per chi sono io, non chi sono io: questo viene dopo. Sì, è una domanda che si deve fare, ma prima di tutto: “perché” fare un lavoro, un lavoro di tutta la vita, un lavoro che ti faccia pensare, che ti faccia sentire, che ti faccia operare. I tre linguaggi: il linguaggio della mente, il linguaggio del cuore e il linguaggio delle mani. E andare sempre avanti.
Maestro anche tu nel tuo libro hai riportato parole simili raccontando ciò che ti disse il direttore del “Ferrante Aporti” il tuo primo giorno: «“Scordati di fare il maestro, qui devi essere il maestro”».
Queste parole le hai commentate già qualche anno fa anche a Radio 3, ma io voglio chiederti: Cosa vuole dire per te essere maestro, esserlo per loro? E tu, Mario, per chi sei?
«Essere maestro per me ha significato aver trovato la mia dimensione, il mio orizzonte di senso. Ho sempre svolto il mio compito senza fatica e con gioia.
Vorrei anch’io citare a questo punto una frase del Buddha che dice pressappoco così: chi è maestro nell’arte del vivere non fa distinzione tra il proprio lavoro e il gioco, fra lo studio e lo svago. Ai suoi occhi lui sta facendo entrambi e lascia agli altri trovare le differenze.
Per loro spero di essere stato un insegnante, cioè di aver lasciato un segno come lo lasciano quelle persone che ricordiamo con affetto e ammirazione.»
Maestro cos’è per te, e quanto conta nel rapporto coi ragazzi, la relazione educativa?
«Senza relazione non c’è azione: se non entri in relazione con gli allievi tutto quello che dici andrà perso “come lacrime nella pioggia”. Ho imparato che perdere tempo ti fa guadagnare tempo. Ascoltare il tuo interlocutore, anche per ore, per altri era una perdita di tempo; per me invece si è rivelato una base fertile su cui impostare il lavoro in aula.»
Maestro come hai fatto tu, in qualità di educatore, a gestire il distacco da quei tuoi ragazzi che un bel giorno sono spariti nel nulla?
«Non è stato facile ma necessario. Troppi ragazzi passavano per l’aula, troppo pochi i giorni per tanti (per fortuna). Per alcuni invece, quando il reato era importante, conoscevi la disgrazia della vita, la sfortuna di nascere in quartieri sbagliati, a latitudini diverse, in famiglie che erano l’origine della disperazione. E qui il tempo scavava solchi profondi che ti restavano dentro, ma col tempo imparavi che non c’era tempo per appianarli perché altri ragazzi si affacciavano all’aula e per tutti bisognava avere una attenzione particolare, un ascolto necessario per sapere cosa fare. Il frequente turnover della classe mi aveva imposto delle priorità: dovevo dare a quei ragazzi gli strumenti per affrontare il mondo sapendo che lo avrebbero affrontato da soli. Imparare a scrivere, a leggere, anche tra le righe, a contare per arrivare anche a dopodomani erano strumenti che non possedevano e senza i quali sarebbero sempre stati dietro agli altri. Non importa se poi un ragazzo non si fa più sentire, chissà dove lo avrà portato la vita, l’importante era che sapesse leggere la vita per essere responsabile delle proprie azioni. È vero, con molti ragazzi sono ancora in contatto, altri mi scrivono, ma se penso alla moltitudine di persone che ho incontrato questi numeri diventano risibili. Mi piace però pensare che un giorno, in una parte remota del mondo, il ragazzo che è transitato per la mia aula si fermi un attimo e dica: “Questo il mio maestro me lo aveva detto!”»
Nel libro “Per fortuna faccio il prof” uscito nel 2018 per i tipi di Bompiani, un tuo collega insegnante, Nando dalla Chiesa, ha scritto:
Quello del professore è mestiere unico. […] Scrigno di memorie senza fine e annuncio senza fine di futuro.
Ci racconti qualcuno dei futuri dei tuoi ragazzi, maestro?
«Molti ragazzi incontrati negli anni ottanta sono cittadini normali, con famiglia e figli; a quei tempi però il lavoro non era un problema e l’origine italiana di quasi tutti facilitava il reinserimento. La grande immigrazione straniera invece ha complicato quel percorso che per un italiano era più semplice. Lo straniero non ha documenti, non è legato ad alcuna città, spesso viene manovrato da italiani o connazionali criminali che sono l’unica possibilità di lavoro. Ciononostante molti si sono affrancati da queste organizzazioni e, cambiando città, si sono reinseriti in percorsi di formazione e lavoro. Alcuni hanno cercato di farcela da soli ed ecco che hanno aperto kebab, imprese di pulizia, importazione di prodotti esotici ecc.
Un ragazzo, che adesso sta a Londra, dopo varie esperienze in Italia, fa il tassista e spesso mi porta in giro per la città quando vado a fargli visita.»
Per quali motivi hai scritto “Il maestro dentro”? Per chi l’hai scritto?
«Prima di tutto me l’hanno chiesto, ma poi ho pensato che, giunto ormai alla fine della mia vita da maestro, potesse servire ai prossimi colleghi come base da cui ripartire. In seguito però ho pensato che non esistono molti libri per adolescenti poco acculturati e che i miei ragazzi difficilmente leggono libri. Quindi ho provato a scriverlo per loro, in modo semplice e chiaro, raccontando storie vere e dentro le quali potessero riconoscersi. La stesura del libro passava anche attraverso il loro giudizio e quando alla fine l’ho portato in aula l’hanno sentito un po’ anche loro. Ogni anno i nuovi colleghi mi chiamano per degli incontri con i ragazzi e noto che il libro è sgualcito, segno che qualcuno l’ha sfogliato e letto.
Attualmente gestisco una rubrica su un blog, www.apassoduomo.it, chiamata “Dietro il muro”.»
Cosa vuol dire per te spendersi per loro? e trascorrere non solo la mattina ma anche i pomeriggi liberi insieme?
«Vuol dire svolgere volentieri e con entusiasmo una professione che non è un lavoro in termini di fatica ma un’esperienza esaltante e sempre nuova. Nessuno mi ha mai imposto i pomeriggi con i ragazzi ma veniva naturale trascorrere altro tempo con loro perché quel tempo era prezioso poi in aula nei giorni seguenti. I ragazzi capivano che non eri lì perché eri pagato per farlo ma stavi in mezzo a loro perché ci stavi bene. Ragazzi spesso rifiutati anche dalle loro famiglie adesso si sentivano preziosi perché una partita a calcio non la si può giocare in tre, ma tutti erano importanti se volevamo fare squadre equilibrate. Certo, c’erano le maglie da distribuire e da raccogliere, i palloni da gonfiare, ma i ragazzi non potevano non apprezzare quello che si faceva per loro al posto di un pomeriggio grigio trascorso a perdere del tempo. Quando in aula avevi bisogno di attenzione ecco che quanto avevi fatto prima diventava prezioso per coinvolgerli in discipline che non avevano mai apprezzato.»
Ragazzi da tutto il mondo, nati in tante diverse nazioni, come li si mette insieme? Com’è incontrare la “differenza” nella fatica di essere un maestro? E, secondo te, la “differenza” è un valore?
«Non li mettevo insieme io, ma i reati che commettevano: furti, scippi, spaccio e consumo di droghe. Quindi un denominatore comune esisteva e da quello partivo per dimostrare che ad ogni latitudine esiste il disagio, il futuro incerto, la paura del domani. Certo non tutto filava liscio, vi erano scontri più che altro nati da pregiudizi o vecchie ruggini che le bande si erano create fuori dal carcere. Ma passata la prima settimana, che erano i giorni più critici, i ragazzi sapevano che in aula potevano stare tranquilli e sereni e a quell’adulto che stava con loro potevano chiedere qualsiasi cosa che fosse legale. Paesi come il Bangladesh, l’Ecuador, la Tunisia, il Marocco, l’Albania, la Romania, la Cina sono nazioni che abbiamo imparato a conoscere a fondo perché avevamo a disposizione la materia prima più importante. Raffronti, uguaglianze, piatti tipici, cultura, era un susseguirsi ogni giorno di discussioni che rendeva la lezione importante anche per me che imparavo più cose in quei momenti che leggendole sui libri di testo. La mia pluriclasse era una ricchezza che l’omologazione dei gruppi come fa la scuola “normale” si può scordare.»
Troppo spesso la scuola è per alcuni ragazzi, come dici tu, «un luogo di sofferenza e di punizione» ancora oggi. Come si fa, secondo te maestro, a dare una mano ai ragazzi a scoprire le proprie doti e i propri talenti affinché possano avere successo e raggiungere i traguardi che desiderano nella vita?
«A priori come si fa non lo so, so però che se passo del tempo ad ascoltarlo, anche se racconta fandonie, prima o poi mi racconterà qualcosa di vero e da quel momento potrò iniziare la mia avventura con lui. La certezza che tutto funzioni non l’avrai mai ma non bisogna cedere come fanno certi prof a scuola che dopo averli bocciati un paio di volte li promuovono per non averli più tra i piedi.»
In una tua intervista su “TV 2000” nel 2019, hai citato Recalcati e “L’ora di lezione” più volte. Anche a te come a me piace leggere le storie di altri maestri, storie di educazione, storie che parlano anche d’affetto tra educatori ed educandi, storie di incontri soprattutto, dentro la scuola e fuori.
Quando dici «facciamo fare loro dei buoni incontri», cosa vuol dire per te maestro?
«La vita mi ha insegnato che è a scuola che si fanno più incontri che in qualsiasi altro luogo. Ma se non frequentiamo la scuola come possiamo fare incontri? Ma se in età scolastica mettiamo un ragazzo in carcere che incontri farà? Ecco perché ho sempre lottato per far entrare più persone [esterne, n.d.r.] nell’istituto penale minorile, in modo che i ragazzi potessero incontrare persone diverse, italiani e stranieri che ce l’avevano fatta dopo momenti difficili, scrittori e personaggi famosi coi quali discorrere seduti allo stesso tavolo. I tornei di calcio organizzati in istituto non erano altro che possibilità di incontro con ragazzi della stessa età e, dopo la partita, si andava tutti quanti nella grande stanza di ricreazione a trascorrere il terzo tempo.»
Conclusione
Lo provocai: «Tu che sei un prete, dimmi un po’: ma don Bosco, a uno così, cosa direbbe?» Don Luciano mi fissò e mi sorrise. > «Non so cosa direbbe a lui, ma so cosa direbbe a te.»
Rimasi di stucco. Aveva ribaltato la situazione.
Era come se il mio attacco mi si fosse ritorto contro. Ma don Luciano non voleva criticarmi. Voleva solo regalarmi qualcosa di prezioso.
«Don Bosco ti direbbe: in ogni ragazzo c’è un punto accessibile al bene.»
— MARCO ERBA, insegnante di scuola superiore, (Erba M., Insegnare non basta, § “La volta che mandai fuori uno studente e poi uscii io”, 2020, Antonio Vallardi Editore)
Ultimo aggiornamento: Tuesday 18 April 2023
Prima redazione: marzo 2023
#maestro #carcere #minori #inclusione #istitutopenitenziario #scuola #pluriclasse #didatticaattiva #tecnologia #intervista