Decrescita, insegnare a non sprecare il mondo
Un antidoto all’idolatria della crescita: con Serge Latouche riscopriamo un’educazione e un design che danno forma a cose, relazioni e comunità destinate a durare.
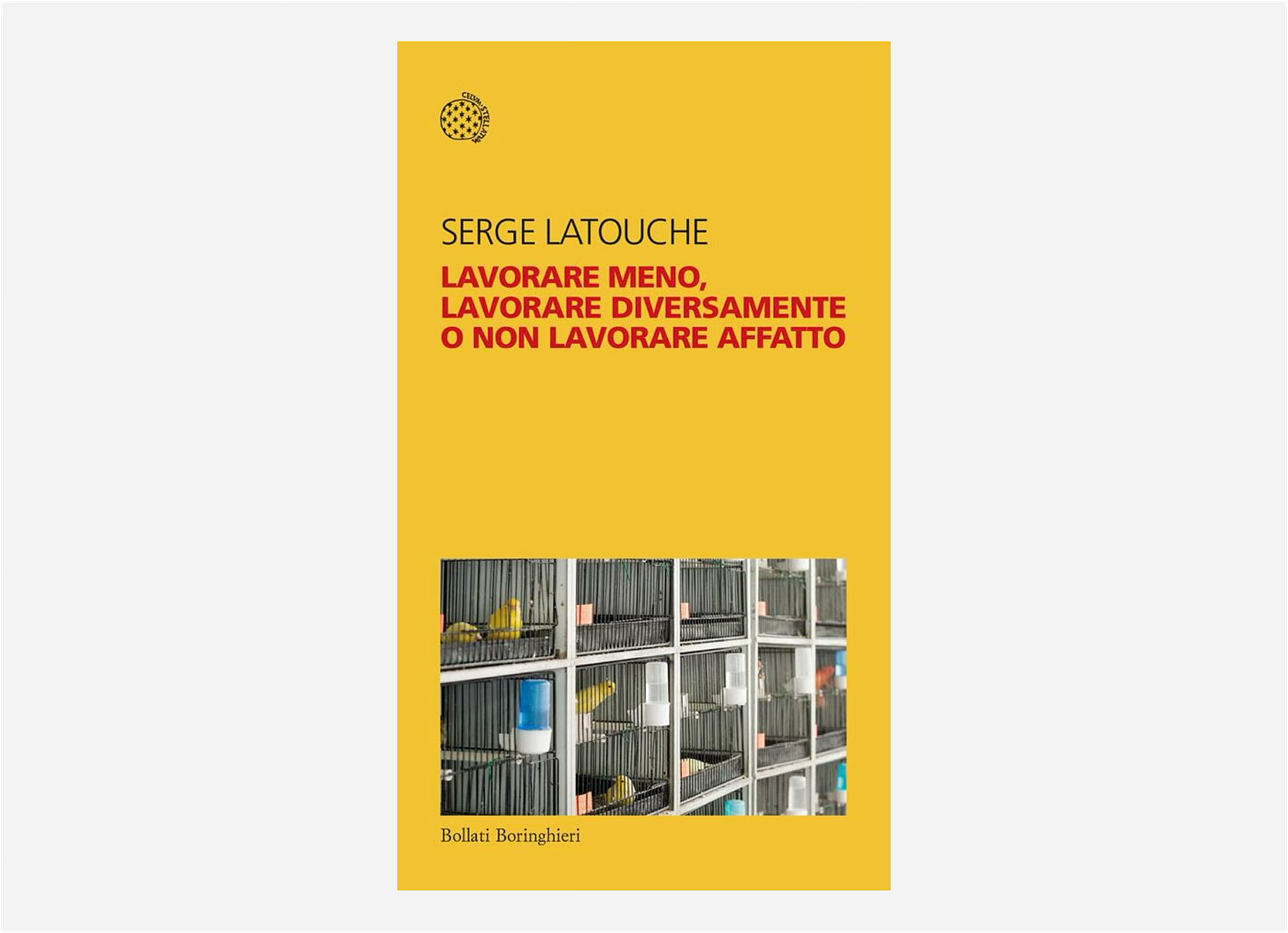
Introduzione
Una recente puntata di Wikiradio, la trasmissione di RAI Radio 3, ci ha spinti – a me e al collega e amico Giorgio Frizzera – a tornare a riflettere sul tema della decrescita, che da anni il professor Serge Latouche propone come alternativa al dogma della crescita illimitata. Non si tratta solo di economia: la decrescita tocca da vicino l’insegnamento, il design, la vendita, e più in generale il modo in cui viviamo e testimoniamo una vita adulta che guarda al futuro dei ragazzi. Le idee di Latouche ci interrogano dunque sul nostro lavoro quotidiano di educatori e progettisti, sulle scelte etiche che facciamo e sul tipo di società che contribuiamo a costruire.
Serge Latouche e l’utopia concreta della decrescita
Ci sono pensatori che continuano a scuotere il dibattito pubblico ben oltre i confini accademici. Serge Latouche è uno di questi. Economista e antropologo francese, è tra i principali interpreti della decrescita: non un invito alla miseria, ma un progetto di liberazione collettiva dall’idolatria della crescita illimitata.
Le sue riflessioni offrono ancora oggi strumenti preziosi per leggere il presente e immaginare alternative. Possiamo raccoglierne alcuni fili essenziali, che parlano direttamente alla nostra quotidianità.
Abbondanza frugale: prosperità senza crescita
Latouche ha coniato l’espressione «abbondanza frugale», che può sembrare un paradosso e invece racchiude la possibilità di una prosperità senza crescita. In questa visione il benessere non è legato all’accumulo ma alla qualità delle relazioni, al tempo liberato, alla sobrietà consapevole.
Per tradurre questa idea in pratica, Latouche ha proposto le celebri otto R: rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare. Otto verbi che diventano un vero e proprio programma politico e culturale, una bussola per chi voglia sottrarsi al totalitarismo consumista. Un’utopia concreta, capace di dare direzione.
La società autonoma ed economa
Un altro aspetto centrale è la visione di una società autonoma ed economa, che Latouche costruisce in dialogo con altri pensatori. Da Cornelius Castoriadis eredita l’idea di una cittadinanza partecipe delle decisioni. Da Ivan Illich l’invito alla pratica delle virtù di una via disciplinata, che sappia porre limiti per proteggere la vita. E da Nicholas Georgescu-Roegen l’intuizione che credere in una crescita infinita in un pianeta finito è una follia: «solo un pazzo o un economista» può pensarlo.
Latouche tesse questi fili in una visione di comunità capaci di rigenerarsi, ridando centralità alla responsabilità civica e alla misura.
La società della crescita e le sue tre illimitatezze
Latouche definisce la società della crescita una macchina biologicamente insostenibile. A condannarla è la sua logica di tripla illimitatezza:
illimitatezza del prodotto da consumare,
illimitatezza dei bisogni da sviluppare,
illimitatezza dei rifiuti da smaltire.
A muovere questa macchina sono tre molle potenti: la pubblicità, che ci fa desiderare cose inutili; il credito, che ci mette in tasca soldi che non abbiamo preparandoci al fallimento; e l’obsolescenza programmata, che rende breve la vita degli oggetti anziché permetterci di ripararli.
In questo ritratto ritroviamo anche temi vicini al design e alla consulenza commerciale, fino a toccare dimensioni spirituali: tutto è collegato, nulla esiste da solo.
Pedagogia delle catastrofi e decolonizzazione dell’immaginario
Latouche non si limita alla diagnosi. Propone una sorta di pedagogia delle catastrofi: imparare a leggere le crisi non come sventure isolate, ma come opportunità di coscienza. Le catastrofi possono aprire gli occhi e spingere a decolonizzare l’immaginario, a liberarci dalle narrazioni tossiche che ci legano al mito della crescita.
Solo riconoscendo i segni del collasso possiamo trasformare la paura in energia per cambiare.
Critica allo sviluppo e all’illusione della sostenibilità
Per Latouche, lo sviluppo economico stesso è un processo etnocida: impone modelli omogenei e cancella culture. L’etichetta di «sviluppo sostenibile» — oggi diremmo greenwashing — è stata usata per rassicurare senza mai mettere in discussione il dogma della crescita.
Già al vertice di Rio del 1992 i grandi dell’industria parlavano la lingua dell’ecologia, appropriandosi delle sue parole. Ma il risultato è stato un imbroglio semantico. L’alternativa non è uno sviluppo “verde”, bensì un diverso modo di vivere, che i popoli indigeni sudamericani chiamano Buen Vivir: un equilibrio comunitario e spirituale con la natura. Per raggiungerlo serve anche una spiritualità laica, nutrita di poesia e arte.
Naomi Klein e la logica catastrofica del capitalismo
Il pensiero di Latouche dialoga con quello della canadese Naomi Klein. In No Logo e Shock Economy Klein ha mostrato come il capitalismo prosperi proprio nelle crisi: ogni catastrofe diventa occasione per rafforzarne le logiche.
Latouche riconosce questo meccanismo e lo inserisce nella sua pedagogia delle catastrofi: se il sistema trae forza dal disastro, è necessario immaginare pratiche che spezzino questo circolo vizioso.
Decolonizzare l’immaginario per cambiare il mondo
In definitiva, il messaggio di Latouche è limpido: non si cambia il mondo senza prima cambiare le immagini con cui lo pensiamo. Le categorie di sviluppo, crescita e consumo hanno colonizzato i nostri desideri e i nostri progetti. Decolonizzare l’immaginario significa liberare spazio per nuove forme di convivenza, giuste e sostenibili.
La decrescita, in questa prospettiva, non è rinuncia ma un invito a vivere meglio: con più tempo, più relazioni, più giustizia. Prima che la crisi climatica ed economica ci travolga, possiamo ancora scegliere una direzione diversa.
Un’utopia concreta, appunto, che chiede poesia e coraggio.



Molto, molto interessante. Come del resto tutti i tuoi articoli! (non commento mai, ma leggo tutto... e mi faccio ispirare)
Sono una fautrice della decrescita, in tutti gli ambiti, ma queste 8 R non le avevo mai incontrate! Grazie.